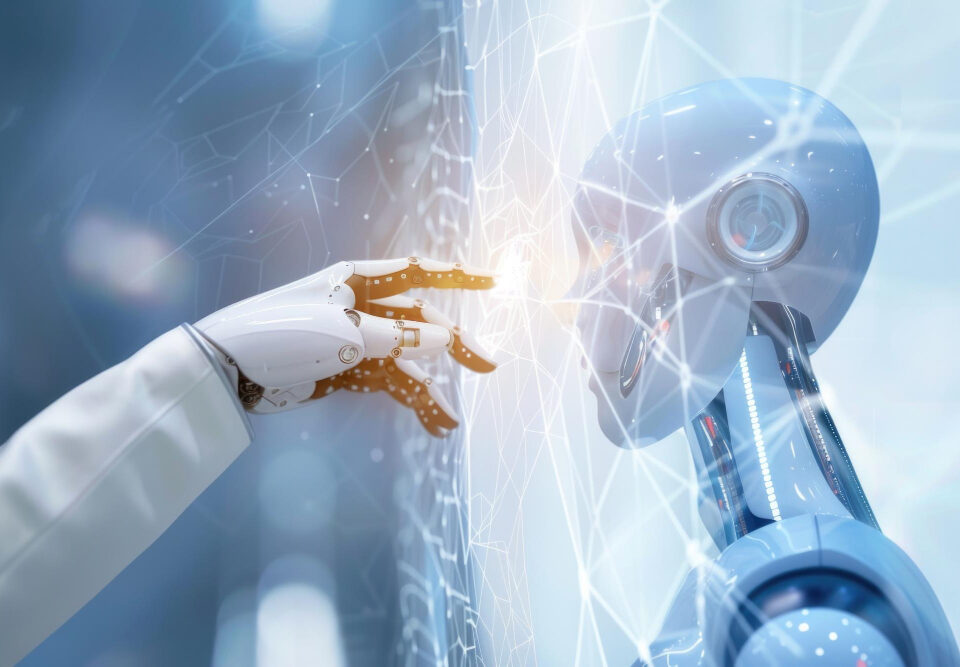- Mail:
- info@digital4pro.com
Il Service Climate: Verso l’integrazione di clima e cultura

IoT: LoRaWAN relay mode
24 Settembre 2025Introduzione
Molloy et al. (2011) hanno trattato in modo assai convincente le difficoltà nell’attraversare i livelli di analisi quando è coinvolta più di una disciplina e Reichers & Schneider (1990) hanno denunciato il fatto che la ricerca sul clima e sulla cultura di quell’epoca fosse caratterizzata da percorsi paralleli, ma non sovrapposti di studio.
Fortunatamente, sia nello studio del clima che nello studio della cultura, sono stati fatti progressi nel superare le difficoltà identificate da Molloy et al. e nel colmare i percorsi paralleli identificati da Reichers e Schneider.
Riavvicinamento tra clima e cultura
Gli psicologi sono passati da uno studio del clima che era a livello di analisi individuale ad un focus unitario e organizzativo.
I ricercatori culturali (ad esempio, Martin 2002) hanno promosso l’idea che le culture possono manifestarsi simultaneamente in modo tale che vi siano esperienze comuni, gruppi di persone con esperienze diverse ed esperienze uniche.
I ricercatori climatici hanno capito che un focus per i loro sforzi (ad esempio, servizio, sicurezza) potrebbero produrre risultati superiori nella ricerca sulla validità rispetto a risultati specifici.
La meta-analisi di Hartnell et al. (2011) del CVF rivela un risultato simile per i ricercatori culturali: un focus sui valori e sul comportamento del quadrante del clan produce una soddisfazione superiore dei dipendenti, mentre un focus sui valori e sul comportamento del quadrante del mercato produce prestazioni operative e finanziarie superiori.
Forse il più degno di nota è Schein che nelle edizioni precedenti del suo libro (1985, 1992) ha appena menzionato il clima (semplicemente raggruppando il clima con gli “artefatti”), ma più di recente (2004, 2010) ha caratterizzato il clima come fornitore di prove comportamentali per la cultura di un ambiente, in modo tale che tali comportamenti costituiscano le basi per le conclusioni dei dipendenti sui valori e le convinzioni che caratterizzano la loro organizzazione. In linea con questa visione, ha affermato nel suo capitolo introduttivo al Handbook of Culture and Climate del 2000 che “per capire cosa succede nelle organizzazioni e perché succede nel modo in cui succede, sono necessari diversi concetti. Clima e cultura, se ciascuno viene definito attentamente, diventano due elementi fondamentali per la descrizione e l’analisi organizzativa” (Schein 2000, pp. xxiv–xxv).
| Tipo di cultura | Ipotesi | Credenze | Valori | Artefatti (comportamenti) | Criteri di efficacia |
| Clan | Affiliazione umana | Le persone si comportano in modo appropriato quando hanno fiducia, lealtà e appartenenza all’organizzazione | Attaccamento, affiliazione, collaborazione, fiducia e supporto | Lavoro di squadra, partecipazione, coinvolgimento dei dipendenti e comunicazione aperta | Soddisfazione e impegno dei dipendenti |
| Adhocrazia | Cambiamento | Le persone si comportano in modo appropriato quando comprendono l’importanza e l’impatto del compito | Crescita, stimolazione, varietà, autonomia e attenzione ai dettagli | Assunzione di rischi, creatività e adattabilità | Innovazione |
| Mercato | Raggiungimento | Le persone si comportano in modo appropriato quando hanno obiettivi chiari e vengono ricompensate in base ai loro risultati | Comunicazione, competizione, competenza e risultati | Raccolta di informazioni su clienti e concorrenti, definizione di obiettivi, pianificazione focalizzazione del compito, competitività e aggressività | Aumento della quota di mercato, profitto, qualità del prodotto e produttivit |
| Gerarchia | Stabilità | Le persone si comportano in modo appropriato quando hanno ruoli chiari e le procedure sono formalmente definite da regole e regolamenti | Comunicazione, routinizzazione, formalizzazione | Conformità e prevedibilità | Efficienza, tempestività e funzionamento regolare |
Tabella 1 – Il quadro dei valori concorrenti.
Il CVF (Hartnell et al. 2011, Quinn e Rohrbaugh 1983) come rappresentato nella Tabella 1 fornisce un possibile quadro per una maggiore integrazione di tale tipo tra le prospettive climatiche e culturali.
I ricercatori del clima hanno accuratamente evitato la valutazione dei valori e delle ipotesi di base, considerandoli forse come “soft” e quindi non immediatamente sotto il controllo della direzione. Certamente i ricercatori del clima potrebbero valutare, oltre a politiche, pratiche e procedure, i valori che queste potrebbero implicare per i membri dell’organizzazione, ad esempio valori per la soddisfazione del cliente.
E i ricercatori della cultura hanno evitato di concentrarsi su criteri specifici, che si tratti di questioni strategiche come la soddisfazione del cliente da un lato o questioni di processo come la fiducia dall’altro.
Un’eccezione può essere trovata nel recente lavoro di Denison, che commercializza un inventario della cultura ben studiato (http://www.denisonconsulting.com/advantage/researchModel/model.aspx) e che ha sviluppato un modulo incentrato sulla fiducia: potrebbe anche naturalmente avere moduli più incentrati su altri risultati o processi, ad esempio, sulla soddisfazione del cliente.
Una caratteristica particolarmente interessante della Tabella 1 è che rivela la varietà di valori e comportamenti che potrebbero essere appropriati per creare una cultura del benessere o una cultura dell’innovazione, e questa nozione di una cultura per qualcosa potrebbe aiutare a rendere il concetto di cultura meno complesso sia nella ricerca che nella pratica.
Ricordiamo che nelle prime ricerche sul clima sembra che il focus per tale lavoro fosse implicitamente un clima per il benessere. Ricordiamo anche che nella revisione del clima operata da Benjamin Schneider, Mark G. Ehrhart e William H. Macey si suggerisce che questo clima per il benessere potrebbe servire come fondamento su cui costruire climi più specificamente focalizzati. Il CVF, seguendo il lavoro di Kuenzi (2008), indica che tale focus sul benessere (una cultura di clan) potrebbe servire come fondamento per più risultati molari, mercato e focus operativi/tecnici, e che questi, a loro volta, potrebbero servire come fondamento per climi strategici più specificamente focalizzati.
Ulteriore integrazione necessaria
Ma mentre il CVF offre il potenziale per una maggiore integrazione della ricerca su clima e cultura e i due approcci sono diventati più simili, ci sono più modi in cui possono imparare l’uno dall’altro e da se stessi.
Ad esempio, per quanto riguarda quest’ultimo, una variabile centrale nei primi scritti sulla cultura organizzativa, le esperienze di socializzazione (Louis 1990, Trice e Beyer 1993), è paradossalmente scomparsa. Nell’edizione del 2000 dell’Handbook of Organizational Culture and Climate (Ashkanasy et al. 2000b), c’era un capitolo di Major (2000) sulla socializzazione, ma la parola non è nemmeno indicizzata nell’edizione del 2011. Non è che la ricerca sulla socializzazione non sia stata condotta. Il problema è che la ricerca si è concentrata principalmente sulle tattiche che gli individui dichiarano di sperimentare durante la socializzazione (vedere la meta-analisi di Bauer et al. 2007) o forse gli effetti della proattività degli individui durante la socializzazione (per una revisione, vedere Bindl & Parker 2010), ma meno il ruolo che la socializzazione svolge nella perpetuazione della cultura organizzativa per i nuovi membri.
In breve, sia le misure culturali che quelle climatiche dovrebbero concentrarsi sulle esperienze di socializzazione dei nuovi arrivati in contesti proprio perché sono nuovi arrivati e tutto ciò che accade loro è nuovo e probabilmente entrerà nella consapevolezza e avrà un impatto a lungo termine (Louis 1990, Scandura 2002, Van Maanen 1975).
La menzione dei nuovi arrivati solleva anche la questione dello sviluppo delle organizzazioni nel tempo e dei conseguenti cambiamenti nel clima e nella cultura che potrebbero essere attesi. Schein (1985, 1992, 2004, 2010) ha costantemente esplorato la questione del ciclo di vita organizzativo e le implicazioni di tale per:
- le richieste di leadership ai manager;
- le culture risultanti che ci si aspetta quando le organizzazioni entrano e attraversano varie fasi della vita.
Le questioni dello sviluppo e dei cicli di vita organizzativi sono notevolmente assenti dalla letteratura sul clima organizzativo. Forse ciò è dovuto all’orientamento più quantitativo dei ricercatori sul clima e alla difficoltà di accedere ai dati in più punti temporali in un lasso di tempo sufficiente per studiare in modo significativo tali questioni, in particolare quando l’attenzione è rivolta a intere organizzazioni e non solo a sottounità. Tuttavia, è necessaria una ricerca in questa direzione.
Presumibilmente, le organizzazioni hanno una strategia chiaramente identificata e comunicata all’inizio del loro ciclo di vita (Flamholtz e Randle 2011), ma man mano che l’organizzazione cresce in termini di numeri e vendite, e forse si espande geograficamente, sarebbe utile sapere come le organizzazioni continuano a mantenere un forte clima strategico. Un altro esempio di ricerca potenzialmente utile in questa direzione sarebbe su come i principali cambiamenti organizzativi come fusioni, acquisizioni o ristrutturazioni influenzino il clima dell’organizzazione e la sua forza.
Una lente utile per esplorare le interrelazioni tra clima organizzativo e cultura è quella del cambiamento organizzativo. La domanda è: se qualcuno volesse cambiare un’organizzazione e migliorarne le prestazioni, dovrebbe cambiare la cultura? Il clima o entrambi? Se ci sono presupposti e valori nell’organizzazione che impediscono all’organizzazione di raggiungere il suo potenziale, allora questi devono essere affrontati. Ma avere semplicemente la cultura “giusta” difficilmente porterà a prestazioni elevate, a meno che il management non abbia creato un clima strategico che comunichi esattamente quali siano gli obiettivi dell’organizzazione e che organizzi i vari processi e procedure nell’organizzazione in base al loro raggiungimento. D’altro canto, gli sforzi del management per creare un clima strategico avranno difficoltà se contraddicono ipotesi profondamente radicate nell’organizzazione (Schein 2000). Un altro modo per pensare a questo problema e dimostrare i collegamenti tra clima e cultura sarebbe quello di chiedersi come il cambiamento venga visto dai dirigenti che sarebbero responsabili di realizzare tale cambiamento. Esploreremo il problema dal punto di vista del dirigente.
Altre ricerche sul tema
A metà degli anni settanta infatti, periodo di ricerca durante il quale la maggior parte dei teorici si concentrava esclusivamente sulla stesura di esaustive rassegne letterarie, Schneider fornì importanti contributi finalizzati a comprendere come reali sotto-climi organizzativi potessero essere utilizzati nella vita organizzativa. Nel tentativo diesplicare la natura nonché le principali funzioni del clima organizzativo, introdusse all’interno di un suo saggio[1] il concetto di “climate for something”(Schneider, 1975).
Sulla stessa linea di pensiero di Schneider, nei periodi successivi, svariati autori (Zohar e Tenne-Gazit, 2008; Litwin e Stringer, 1968; Shacklock, Manning e Hort, 2011; Schneider e Bowen, 1985; Schneider, Parkington, e Buxton, 1980; Schneider, White e Paul, 1998) hanno perseguito tale approccio diffondendo costrutti finalizzati ad una restrizione nonché specificazione degli ambiti di analisi a seconda del criterio di interesse: ne sono esempi il safety climate, il climate for achievement, l’ethical climate, il climate for implementation nonché il service climate, il quale trovapertinente applicazione nelle analisi del clima presente nel momento in cui si “serve” un cliente (D’Amato e Majer,2005; Manning et al., 2012).
In merito a quest’ultimo, è possibile riconoscerne la sua rilevanza grazie ad uno dei tanti studi svolti in materia: all’inizio degli anni Novanta, ad esempio, Reichheld e Sasser (1990) constatarono che riducendo eventuali errori nella fornitura di un servizio assicurativo anche solo di appena il 5%, le imprese potevano registrare profitti maggiori di circa l’85%. Molte organizzazioni, pertanto, hanno iniziato ad intravedere la qualità del servizio o l’eccellenza dei servizi come unapotente variabile strategica (Schneider, 1990).
Implicazioni pratiche
I dirigenti hanno poca preoccupazione per le distinzioni che abbiamo fatto tra cultura e clima. In effetti, cultura è il loro termine comunemente utilizzato.
Ad esempio, in seguito alla catastrofe di Texas City della BP del 2005, il comitato indipendente, ampiamente noto come Baker Committee, ha condotto una revisione della “cultura della sicurezza” della BP. Il rapporto che ne è seguito (Baker et al. 2007) include il contenuto dell’elemento di un “sondaggio sulla cultura della sicurezza” preparato da una società di consulenza indipendente. Questo sondaggio è un chiaro esempio di un sondaggio sul clima della sicurezza, con la sua attenzione su politiche, pratiche e procedure e comportamenti che (non) vengono premiati, supportati e attesi. Il comitato lo chiama sondaggio sulla cultura perché implicitamente comprende che:
- l’interesse esecutivo nella “cultura aziendale” è nella creazione di processi che rafforzano i valori fondamentali alla base della strategia esistente;
- una strategia mirata richiede processi incentrati su risultati apprezzati (come la sicurezza);
- solo con la creazione di tali processi i valori vengono effettivamente incorporati e diventare autosufficienti all’interno dell’organizzazione per fungere da punti di riferimento per i membri dell’organizzazione.
Pertanto, gli scrittori di business popolari contemporanei ritengono che la cultura aziendale abbia il potenziale per “sopravvivere a qualsiasi leader carismatico” (Heskett et al. 2008). In breve, i dirigenti utilizzano la cultura aziendale in un modo più ampio di quanto abbiamo articolato in termini di opinioni accademiche che abbiamo presentato. Dal punto di vista conversazionale, il vocabolario aziendale esteso abbracciato dal termine cultura include un’ampia gamma di attività immateriali (o passività) come immagine, marchio e simili. Tali quadri idiosincratici potrebbero non avere un fondamento nell’erudizione, ma servono comunque come quadri di riferimento operativi per la cultura come interpretata dai dirigenti. Le questioni importanti per i dirigenti sono:
- conoscere la cultura aziendale;
- cambiare la cultura aziendale;
- sfruttare la cultura aziendale per creare un vantaggio competitivo.
Le questioni di “conoscenza” sono rilevanti perché il valore della cultura, come tutti i beni immateriali, è sconosciuto. Sia gli sforzi per cambiare che per sfruttare la cultura dipendono in effetti dalla comprensione di cosa sia quella cultura e forse dalla direzione in cui si sta muovendo, un’osservazione su cui torneremo tra poco.
Conoscere la cultura
Naturalmente, i dirigenti sono agnostici rispetto a come misurare al meglio la cultura. Tuttavia, si preoccupano della capacità di fare confronti, il che porta a una naturale inclinazione ad assumere consulenti che possono fornire confronti con parametri di riferimento (ad esempio, confronti di settore, confronti con le liste delle migliori aziende per cui lavorare o delle aziende più ammirate) che più li interessano. Qui è essenziale una misura quantitativa che può essere caratterizzata da un numero finito di dimensioni che sono comuni a diverse organizzazioni, con i costrutti misurati che variano notevolmente.
È interessante ipotizzare che i dirigenti scelgano misure della loro cultura più in linea con i valori che desiderano sostenere e i loro risultati strategici di interesse alla Quinn & Rohrbaugh (1983) CVF, e che meglio si adattano a un bisogno sentito di conoscenza su una sfaccettatura specifica della cultura/clima (come sicurezza o servizio). I dirigenti che credono che la cultura sia importante acquistano tali misure e agiscono sui risultati a causa delle loro convinzioni nell’importanza dell’intangibile che affrontano in tutte le loro attività.
Da un punto di vista pratico, come da un punto di vista accademico, l’enfasi sugli intangibili rende insoddisfacente per i dirigenti un affidamento completo su approcci quantitativi. Ciò è vero perché il vocabolario stesso che viene imposto da tali misure alla descrizione della cultura può essere molto diverso da quello utilizzato da coloro che la sperimentano (Denison e Spreitzer 1991). In effetti, sembra ragionevole prevedere che il futuro relativamente a breve termine della misurazione della cultura possa spostarsi verso le riflessioni ad hoc basate sul testo di spiegazioni verbali e scritte catturate attraverso la meccanica di elaborazione del linguaggio naturale ora in voga per misurare il sentimento politico e dei consumatori (ad esempio, Pang e Lee 2008).
Cambiare la cultura
Conoscere la cultura è quasi sempre considerato nel contesto di un bisogno percepito di cambiamento culturale o per garantire la conservazione di ciò che è ritenuto fondamentale per il modo in cui l’organizzazione crea valore. In effetti, gli interventi incentrati sul cambiamento culturale spesso si concentrano sulla chiusura del divario tra culture esistenti e desiderate, e questi vengono in genere catturati nelle misure chiedendo agli intervistati entrambi i tipi di dati.
L’assunto di base è che, con la conoscenza, la cultura può essere cambiata attraverso l’azione giusta. I dirigenti capiscono implicitamente di avere un’influenza diretta piuttosto limitata sull’attuazione del cambiamento perché molti problemi devono essere affrontati simultaneamente in tutta l’azienda. Il loro compito è stabilire la missione e supportare gli interventi necessari per incorporare i processi necessari per iniziare il riorientamento, comprendendo sempre che forze sociali ed economiche più ampie svolgono un ruolo significativo in ciò che sono e in ciò che possono diventare (Burke 2011).
Di per sé, il cambiamento è sfuggente da misurare e, come tale, i modelli di cultura aziendale includono dimensioni che riflettono costrutti come adattabilità; in effetti, Kotter e Heskett (1992) fanno dell’adattabilità una caratteristica centrale dell’efficacia organizzativa, sostenendo che il cambiamento odierno precede necessariamente la necessità di cambiare domani. Vale la pena aggiungere che l’interesse pratico non è solo nella direzione del cambiamento, ma anche nel ritmo di tale cambiamento (Flamholtz e Randle 2011).
Sfruttare la cultura per un vantaggio competitivo
Il tema di fondo di molte conversazioni sulla cultura è come può essere sfruttata come risorsa. La cultura è un focus per il vantaggio competitivo quando è diversa da altre culture e gli elementi che la costituiscono sono difficili da imitare (Ployhart 2012). “Gli elementi che la costituiscono” si basano sui processi che si radicano attraverso la conoscenza e il cambiamento con i climi risultanti che creano per i comportamenti richiesti per il successo. La cultura, quindi, produce un vantaggio competitivo come risultato di un ciclo che inizia con lo sviluppo di una dichiarazione di missione unica, attuata dal supporto per i processi unici necessari per incorporare i valori della missione e creare i climi strategici e di processo mirati che fungono da linee guida per il comportamento. In breve, fare meglio di ciò che fanno gli altri non è la chiave per il vantaggio competitivo. In sintesi, i dirigenti di maggior successo comprendono implicitamente come il clima e la cultura siano necessariamente collegati e i complessi passaggi richiesti per ottenere un vantaggio competitivo. Quando la cultura ricercata è unica, quando i climi creati sono unici nella loro complessa attenzione simultanea su importanti processi organizzativi interni (ad esempio, correttezza, etica, inclusione) e risultati strategici (ad esempio, servizio, sicurezza, innovazione), allora il vantaggio competitivo è possibile. Una soluzione miracolosa non esiste ancora e i dirigenti migliori conoscono e comprendono questa verità.
Conclusioni
Il clima e la cultura organizzativa offrono prospettive sovrapposte per comprendere i tipi di esperienze integrative che le persone hanno in contesti lavorativi, o in qualsiasi contesto organizzativo. I costrutti affrontano il significato che le persone attribuiscono alle loro esperienze su come funziona l’organizzazione (climi di processo), i focus strategici dell’organizzazione (climi strategici) e i valori che attribuiscono al contesto (cultura), il tutto nel tentativo di dare un senso alle loro esperienze (Weick & Quinn 1999). La letteratura sul clima si è concentrata su ciò che Schein (2010) chiama i meccanismi di radicamento della cultura delle organizzazioni, i tangibili messi in atto dai leader con cui esprimono i loro valori e i presupposti di base (Quinn & Rohrbaugh 1983) e con cui tentano di focalizzare le energie e le competenze delle persone nel contesto. Questi processi e attività sono progettati per produrre comportamenti che perseguono obiettivi e scopi organizzativi, e sono questi comportamenti che finiscono per caratterizzare intere organizzazioni e sottoculture al loro interno (Martin 2002).
Negli ultimi 25 anni, gli studiosi del clima si sono occupati di politiche, pratiche e procedure più tangibili come cause delle esperienze delle persone, concentrando i loro sforzi sulla comprensione di come i lavoratori sperimentano le iniziative strategiche della gestione (ad esempio, servizio, sicurezza, innovazione) e i processi interni che le accompagnano (ad esempio, correttezza, etica, inclusione). Ora sono stati fatti progressi nel comprendere quando le persone non sono d’accordo su quei climi (ad esempio, forza del clima), ma non c’è molto lavoro per concettualizzare e comprendere come i climi multipli nelle organizzazioni interagiscono e/o addirittura entrano in conflitto tra loro (Kuenzi e Schminke 2009).
Gli studiosi della cultura hanno preso due direzioni nei loro sforzi per concettualizzare e comprendere la cultura organizzativa.
- Quando la cultura viene studiata come qualcosa che le organizzazioni sono, l’attenzione è rivolta alla loro unicità e a ciò che le specifiche peculiarità dei loro “artefatti” (ad esempio, miti, storie e tattiche di socializzazione) ci dicono sui valori e sulle ipotesi di base delle persone lì presenti.
- In alternativa, quando la cultura viene studiata come qualcosa che le organizzazioni hanno, la ricerca comparativa sulla cultura organizzativa produce valutazioni quantitative dei modi in cui le organizzazioni mostrano i loro valori e le ipotesi di base sulle persone, i risultati, la formalizzazione e la crescita (alla maniera del quadro dei valori concorrente mostrato nella Tabella 1).
I sondaggi progettati per valutare queste inclinazioni hanno molto in comune con i sondaggi sul clima, con il CVF che fornisce più attenzione per tali valutazioni rispetto a quanto è stato vero per la ricerca sulla cultura in passato.
Ovviamente vediamo queste due prospettive come modi utili per concettualizzare e comprendere le esperienze delle persone sul lavoro. Il clima offre un approccio ai tangibili su cui i manager possono concentrarsi per generare i comportamenti di cui hanno bisogno per l’efficacia, e la cultura offre gli intangibili che probabilmente si accumulano per produrre la psicologia più profonda delle persone in un contesto.
La psicologia di come le persone vivono il loro ambiente di lavoro è difficile da valutare, ma è probabilmente ciò che le indirizza implicitamente nella loro vita quotidiana, quindi è importante capirla. Quando è necessario un cambiamento in ciò che indirizza le persone e la loro vita quotidiana, allora concentrarsi sui tangibili è il modo per ottenerlo. Pertanto, la connessione concettuale tra clima e cultura è chiara e meritevole di future ricerche.
Bibliografia
- http://rolandociofi.wordpress.com/2011/06/03/il-clima-organizzativo-di-matteo- ciancaleoni
- https://psyjob.it/clima_organizzativo.htm
- ALDRICH, , & HERKER, D., (1977), Boundary-spanning roles and organization structure. Academy ofManagement Review, 2: 217-230.
- ADKINS A., (1999), Promoting organizational health: The evolving practice of occupational healthpsychology. Professional Psychology: Research and Practice. 30:129–37.
- AZZARITI , BASSINI M., NOVELLO C., (2009), Ma che freddo fa. Appunti, esperienze, evoluzioni intema di meteorologia organizzativa, FrancoAngeli, Milano.
- BASAGLIA S., PAOLINO C. (2015) Clima aziendale. Crescere dando voce alle persone. EGEA, Milano
- BELL, P., (2011), Diversity in Organizations. Florence, KY: Cengage Learning.
- BOLOGNINI (2006), L’analisi del clima organizzativo, Carocci editore, Milano.
- BOWEN E., OSTROFF C., (2001), “Understanding HRM–firm performance linkages: the role of the strengthof the HRM system,” Academy of Management Review, vol. 29, no. 2, pp. 203-221.
- BOWEN, D.E. AND SCHNEIDER, B. (2014), “A service climate synthesis and future research agenda”, Journal ofService Research, 17 No. 1, pp. 5-22.
- BROWN W., SWARTZ T. A., (1989), “A gap analysis of professional service quality,” Journal of Marketing, vol. 53, no. 2, pp. 92-98.
- CAMPBELL J., (1970), Managerial behavior, performance, and effectiveness, McGraw-Hill, New York.
- CARRASCO , MARTÍNEZ-TUR V., PEIRÓ J.M., MOLINER C., (2012), Validación de una Medida de Clima de Servicio en las Organizaciones,Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, 28: 69-80
- CHATMAN A., (2010), Norms in Mixed Sex and Mixed Race Work Groups, Academy of Management Annual
- CHOI Y., DICKSON D., (2010) “A case study into the benefits of management training programs: impacts on hotelemployee turnover and satisfaction level,” Journal of Human Resources in Hospitality & Tourism, 9, pp.103-116.
- COX, , JR. (1993). Cultural diversity in organizations: Theory, research & practice. San Francisco, CA: Berrett-Koehler.
- COX, , JR., & BEALE, R. L. (1997), Developing competency to man- age diversity: Readings, cases &activities. San Francisco, CA: Berrett-Koehler.
- DAVIDSON, C. G. (2003). Does organizational climate add to service quality in hotels? InternationalJournal of Contemporary Hospitality Management, 15(4), 206-213.
- D’AMATO , MAJER V., (2005), Il vantaggio del clima, Raffaello Cortina Editore, Milano.
- DION, K.L., (1989), Ethnicity and perceived discrimination: “A comparative survey of six ethnic groups in Toronto”, Paper presented at the Biennal conference of the Canadian ethnic Studies Association, Calgary, Alta.
- DITOMASO , POST C., PARKS-YANCY R., (2007), Workforce diversity and Inequality: Power, Status, andNumbers, Annual Review of Sociology, 33: 473-501
- DWERTMANN J. G., NISHII L. H., KNIPPENBERG D.V., (2016), Disentangling the Fairness & Discriminationand Synergy Perspectives on Diversity Climate: Moving the Field Forward, Journal of Management, pp. 1–33
- DYER, L. & REEVES, T. (1995) Human resources strategies and firm performance: what do we know and wheredo we need to go? International Journal of Human Resource Management6(3), pp 656-670.
- EISENBERGER , HUNTINGTON R., HUTCHISON R., SOWA D., (1986), Perceived OrganizationalSupport, Journal of Applied Psychology, 71:500-507
- ELY R. J., THOMAS D. A., (2001), Cultural Diversity at Work: The Effects of Diversity Perspectives on Work Group Processes and Outcomes, Administrative Science Quarterly, 46: 229-273
- FOREHAND G. A., GLIMER B.H. (1964) “Enviornmental variation in studies of organizational behavior”,Psicological Bulletin, 62 (6), pp. 205-222.
- FORMISANO , (2009) Analisi del clima organizzativo: il caso di un istituto di credito.
- FURDHAM E GOODSTEIN L.D. (1997), “The Organizational Climate Questionnaire”
- GABRIELLI (2010), People Management. Teorie e pratiche per una gestione sostenibile delle persone, Franco Angeli, Milano
- GABRIELLI , PROFILI S., (2012), Organizzazione e gestione delle risorse umane, Isedi, Torino
- GARDENSWARTZ L.; ROWE A., (1994), Diversity management: Practical application in a health careorganization, Frontiers of Health Services Management, 11: 36-40.
- GELFAND J., EREZ M., AYCAN Z., (2007), Cross-Cultural Organizational Behaviour, Annual Review Psychology, 58:479–514
- GIDDENS, SUTTON (2013), Sociology, Polity
- GLICK H., (1985), Conceptualizing and Measuring Organizational and Psychological Climate: Pitfalls inMultilevel Research, The Academy of Management Review, 10:601-616 GOYAL S., SHRIVASTAVA S., (2013), Organizational Diversity Climate: Review of Models and Measurement, Journal of Business Management &Social Sciences Research, 2:2319-5614.
- HE, , LI, W., AND LAI, K. K. (2011). Service climate, employee commitment and customer satisfaction.International Journal of Contemporary Hospitality Management, 23(5), 592-607. HELLRIEGEL D., SLOCUMJ.W., (1974) “Organizational Climate: Measures, Research and Contingencies”, Academy of ManagementJournal, 17: 255-280.
- HENRY I.G., (2017), “Organizational climate and organizational commitment of deposit money banks in riversstate”, International Journal of Advanced Academic Research, 3: 18-30
- HESKETT, , SASSER W. E. JR., SCHLESINGER L., (1977), The Service Profit Chain: How LeadingCompanies Link Profit and Growth to Loyalty, Satisfaction, and Value. New York: Free Press.
- HICKS-CLARKE, D., AND ILES P., (2000), “Climate for diversity and its effects on career and organisationalattitudes and ” Personnel Review, vol. 29, no. 3, pp. 324 – 345.
- HOFHUIS , VAN DER RIJT P. G. A., VLUG M., (2016), Diversity climate enhances work outcomes throughtrust and openness in workgroup communication, SpringerPlus 2016.
- HOLVINO E., FERDMAN B.M. E MERRILL-SANDS D., (2004) Creating and sustaining diversity and inclusion in organizations: strategies and approaches, in The Psychology and Management of Workplace Diversity, (2004)edited by Stockdale S. e Crosby F.J.
- HONG Y, LIAO H, HU J, JIANG , (2013), Missing link in the service profit chain: a meta- analytic review of theantecedents, consequences, and moderators of service climate, Journal of Applied Psychology, 98:237-67.
- HUBBARD, E., (2012), The Diversity Scorecard: Evaluating the Impact of Diversity on Organizational Performance.New York, NY:
- HUNG, K. (2006). The impact of human resource management practices on service performance of Taiwanese hotel industry – organizational commitment as a mediator. International Journal of the Informationsystems for Logistics and Management, 1(2), 109- 116.
- INNOCENTI L., (2013) Clima organizzativo e gestione delle risorse umane. Unire persone e performance, FrancoAngeli, Milano
- JAMES , JONES A., (1974), “Organizational Climate: A review of Theory a Research”, PsychologicalBulletin, 81: 1096-1112.
- JOHNSON V., (1996), Linking Employee Perceptions Of Service Climate To Customer Satisfaction,Personnel Psychology, 49.
- KOSSEK, E., & ZONIA, S. C. (1993). Assessing diversity climate: A field study of reactions to employer efforts topromote diversity, Journal of Organizational Behavior, 14:61–81
- KOSSEK E., ZONIA S.C., YOUNG W., (1996), The limitations of organizational demography: can diversity climate be enhanced in the absence of teamwork?, in RUDERMAN M.N., HUGHES-JAMES M.W., JACKSON S.E., Selected research on work team diversity, American Psychology association, pp. 121-150
- KRAMER R.M. (1999), Trust and Distrust in Organizations: Emerging Perspectives, Enduring Questions, Annual Review of psychology, 50:569-598
- LEE, W., MITCHELL. T. R., WISE, L. & FIREMAN, S. (1996). An unfolding model of voluntary employeeturnover. Academy of Management Journal, 39, 5- 36.
- LEE, Y-K, NAM, J-H, PARK, D-H., & LEE, A. (2006). What factors influence customer- oriented prosocial behavior of customer-contact employees? Journal of Services Marketing, 20(4), 251-264.
- LEFTON M., ROSENGREN W.R., (1966), Organizations and Clients: Lateral and Longitudinal Dimensions,American Sociological Review, 31: 802-810
- LEWICKI R.J., MCALLISTER D., BIES R. (1998), Trust and Distrust: New Relationships and Realities, Acadedy ofManagement Review, 23: 439-458
- LEWIN , (1939), “Field Theory and Experiment in Social Psychology: Concepts and Methods”, AmericanJournal of Sociology, 44: 868-896.
- LEWIN, K., (1946) Action research and minority problems, in G.W. Lewin (Ed.) Resolving Social Conflicts. NewYork: Harper &Row (1948).
- LITWIN G.H., STRINGER, R.A. (1968), Motivation and Organizational Climate, Harvard University, GraduateSchool of Business Administration,
- LOCKE, A. (1976) The Nature and Causes of Job Satisfaction. In: Dunnette, M.D., Ed., Handbook ofIndustrial and Organizational Psychology, Vol. 1, 1297-1343.
- LYTLE R., HOM P., MOKWA M., (1998). SER∗OR: A managerial measure of organizational service-orientation. Journal of Retailing, 74, 455–489.
- MAJER , D’AMATO A. (2001), “M_DOQ Majer D’Amato Organizational Questionnaire”, Unipress, Padova.
- MANNING, L., DAVIDSON, M., & MANNING, R. L. (2005). Measuring tourism and hospitality employeeworkforce perceptions. Hospitality Management, 24, 75-90.
- MAYER R.C., DAVIS J.H., SCHOORMAN F.D. (1995), An integrative model of organizational trust, Academy of Management Review, 20: 709-734
- MCKAY F., AVERY D. R., MORRIS M. A., (2008), Mean racial-ethnic differences in employee sales performance: the moderating role of diversity climate, Personnel Psychology, 61:349–374
- MCKAY F., AVERY D.R., MORRIS M.A., (2009), A tale of two climates: Diversity Climate from subordinates’ and Managers’ Perspectives and their Role in store unit sales Performance, Personnel Psychology, 62: 767-791
- MINTZBERG H., (1980), Structure in 5’s: A Synthesis of the Research on Organization Design, Management Science, 26: 322-341
- MORAN T., VOLKWEIN, J.F. (1992), “The Cultural Approach to the Formation of Organizational Climate”, Human relations, 45: 19-47.
- MOR BARAK M.E.M., CHERIN D.A., BERKMAN S. (1998), “Organizational and Personal Dimensions in DiversityClimate Ethnic and Gender Differences in Employee Perceptions”, The Journal of Applied BehavioralScience, 34: 82-104.
- MOR-BARAK M.E., CHERIN D.A., (1998), A Tool to Expand Organizational Understanding of Workforce Diversity,Administration in Social Work, 22: 47-64
- MUMBY, D. K. (1988), Communication and paper in organizations: Discourse ideology and nomination in T.Moran, J.F. Volkwein (1992), “The Cultural Approach to the Formation of Organizational Climate”, Humanrelations, 45: 19-47.
- NISHII H., (2013), The Benefits Of Climate For Inclusion For Gender-Diverse Groups, Academy ofManagement Journal, 56: 1754–1774
- OSMAN R., SAHA J., ALAM M.M.D., (2017), The Impact of Service Climate and Job Satisfaction on Service Quality in a Higher Education Platform, International Journal of Learning and Development, 7: 2164-4063
- PARASURAMAN, , ZEITHAML, V.A. AND BERRY, L.L. (1985), “A conceptual model of service quality and itsimplication for future research”, Journal of Marketing, No. 49, April, pp. 41-50.
- PARKINGTON J.J.,SCHNEIDER B.,(1979), Some Correlates of Experienced Job Stress: A Boundary Role Study,Academy of Management Journal, 22:270-281
- PATTERSON M., WEST M.A., SHACKLETON V.J., DAWSON J.F, LAWTHOM R., MAITLIS
- , ROBINSON D.L., WALLACE A.M. (2005), “Validating the organizational climate measure: links tomanagerial practices, productivity and innovation” Journal of Organizational Behavior, 26:379–408
- PRITCHARD D. KARASICK B. W., (1973), The effects of organizational climate on managerial jobperformance and job satisfaction, Organizational Behavior and Human Performance, 9:126-146
- PUGH D., JACK J. D., WILEY W., SCOTT M. B., (2002), “Driving service effectiveness through employee-customer linkages”, Academy of Management Executive, vol. 16, no. 4, pp. 73-84.
- QUAGLINO P., MANDER M., (1987), I climi organizzativi, Il Mulino, Bologna.
- REICHHELD, F., & SASSER, W. E., JR. (1990). Zero defections: Quality comes to services. Harvard BusinessReview, 68:105–111.
- REICHERS, E., & SCHNEIDER, B. (1990). Climate and culture: An evolution of constructs. In B. Schneider (Ed.), Organizational climate and culture (pp. 5–39). San Francisco: Jossey- Bass.
- REYNOSO , MOORES B., (1995) “Towards the measurement of internal service quality”, InternationalJournal of Service Industry Management, Vol. 6 Issue: 3, pp.64-83.
- RHOADES L., EISENBERGER R., (1986), Perceived Organizational Support: a review of the literature, Journal of Applied Psychology, 87: 698-714
- SHANKA T., HOSSAIN M. E., QAUDDUS M. A., (2012), “Perceived quality, satisfaction, and loyalty at the destination level of cox’s bazar, Bangladesh” Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics.
- SHORE M., RANDEL A.E., CHUNG B.G., DEAN M.A., EHRHART K. H., SINGH G., (2011), Inclusion andDiversity in Work Groups: A Review and Model for Future Research, Journal of Management, 37: 1262-1289
- SCHNEIDER , BARTLETT, C.J. (1968), “Individual Differences and Organizational Climate I: The ResearchPlan and Questionnaire Development”, Personnel Psychology, 21: 323-333.
- SCHNEIDER, (1973), “The perception of organizational climate: The customer’s view”, Journal ofApplied Psychology, Vol. 57 No. 3, pp. 248-256.
- SCHNEIDER, (1975). Organizational climates: an essay. Personnel Psychology, 28, 447–479
- SCHNEIDER, , PARKINGTON, J.P. AND BUXTON, V.M. (1980), “Employee and Customer Perceptions ofService in Banks”, Administrative Sciences Quarterly, Vol. 25 No. 2, pp. 252- 257.
- SCHNEIDER, (1980), “The Service Organization: Climate Is Crucial”, Organizational Dynamics, Vol. 9 No. 2, pp. 52-65.
- SCHNEIDER, B., & REICHERS, A.E. (1983). On the etiology of climates. Personnel Psychology, 36, 19-39.
- SCHNEIDER, B. AND BOWEN, D.E. (1985), “Employee and Customer Perceptions of Service in Banks:Replication and Extension”, Journal of Applied Psychology, 70 No. 3, pp. 423-433.
- SCHNEIDER, (1990), The climate for service: An application of the climate construct. In: Schneider, B.(ed.) Organizational climate and culture. Jossey-Bass, pp. 383-412.
- SCHNEIDER, , WHEELER, J.K. AND COX, J.F. (1992), “A passion for service: Using content analysis toexplicate service climate themes”, Journal of Applied Psychology, Vol. 77 No. 5, pp. 705-716.
- SCHNEIDER , BOWEN D. E., (1993) “The service organization: Human resources management is crucial,”Organizational Dynamics, vol. 21, pp. 39-52.
- SCHNEIDER, B., WHITE, S. S., & PAUL, M. C. (1998). Linking service climate and customer perceptions ofservice quality: test of a causal Journal of Applied Psychology, 83(2), 150-163.
- SCHNEIDER, , SALVAGGIO, A.N. AND SUBIRATS, M. (2002), “Climate strength: a new direction for climateresearch”, Journal of Applied Psychology, Vol. 87 No. 2, pp. 220.
- SCHNEIDER, , EHRHART, M.G., MAYER, D.M., SALTZ, J.L. AND NILES-JOLLY, K. (2005), “Understandingorganization-customer links in service settings”, Academy of Management Journal, Vol. 48 No. 6, pp. 1017-1032.
- SCHNEIDER, , MACEY, W.H. AND YOUNG, S.A. (2006), “The climate for service: A review of the constructwith implications for achieving CLV goals”, Journal of Relationship Marketing, Vol. 5 No. 2-3, pp. 111-132.
- SCHNEIDER, B., EHRHART, M.G. AND MACEY, W.H. (2013), “Organizational climate and culture”, Annual reviewof psychology, 64 No., pp. 361-388.
- SCHWARTZ, S.H. (1994), Beyond individualism/collectivism: New cultural dimensions of values. In: KIM, ,TRIANDIS, H.C., KAGITCIBASI, C., CHOI, S. AND YOON, G. (eds.) Individualism and collectivism: Theory,method, and applications. Thousand Oaks, CA: Sage, pp. 85- 119.
- SIMONS T., (2002), Behavioural Integrity: The Perceived Alignments Between Managers’ Words and Deeds as aResearch Focus, Organisation Science, 13: 18-35
- SPALTRO (1977), Lotta contro e lotta per, Celuc Libri, Milano.
- SPALTRO E., DE VITO PISCICELLI P., (2002) Psicologia per le organizzazioni, Carocci, Roma. STORBACKA ,STRANDVIK T., GRÖNROOS C., (1994), Managing Customer Relationships for Profit: The Dynamics ofRelationship Quality, International Journal of Service Industry Management, 5:21-38.
- SUSSKIND M., KACMAR K.M., BORCHGREVINK C.P. (2003) Customer Service Providers’ AttitudesRelating to Customer Service and Customer Satisfaction in the Customer–Server Exchange, Journal of Applied Psychology 88: 179–187
- TAGIURI , PETRULLO L. (Eds.), Person perception and interpersonal behavior, Stanford University Press. (pp. 54-62).
- TETT RP, BURNETT (2003) A personality trait-based interactionist model of job performance,Journal of Applied Psychology, 88:500-17.
- TURNER, C., & TAJFEL, H. (1986). The social identity theory of intergroup behavior. Psychology of intergroup relations, 7-24.
- WIRTZ J., KIMES S., THENG J. H. P., PATTERSON P., (2003), “Revenue management: resolving potential customer conflicts,” Journal of Revenue and Pricing Management, vol. 2, no. 3, pp. 216-226.
- YEO, (2006). “Measuring organizational climate for diversity: a construct validation approach. Dissertation.”Graduate School of The Ohio State University.
- YU C. H., CHANG H. C., HUANG G. L., (2006), “A study of service quality, customer satisfaction and loyalty in Taiwanese leisure industry,” Journal of American Academy of Business, Cambridge, vol. 9 no. 1, pp.126-132.
Note
[1] Schneider, B. (1975). Organizational climates: an essay. Personnel Psychology, 28, 447–479