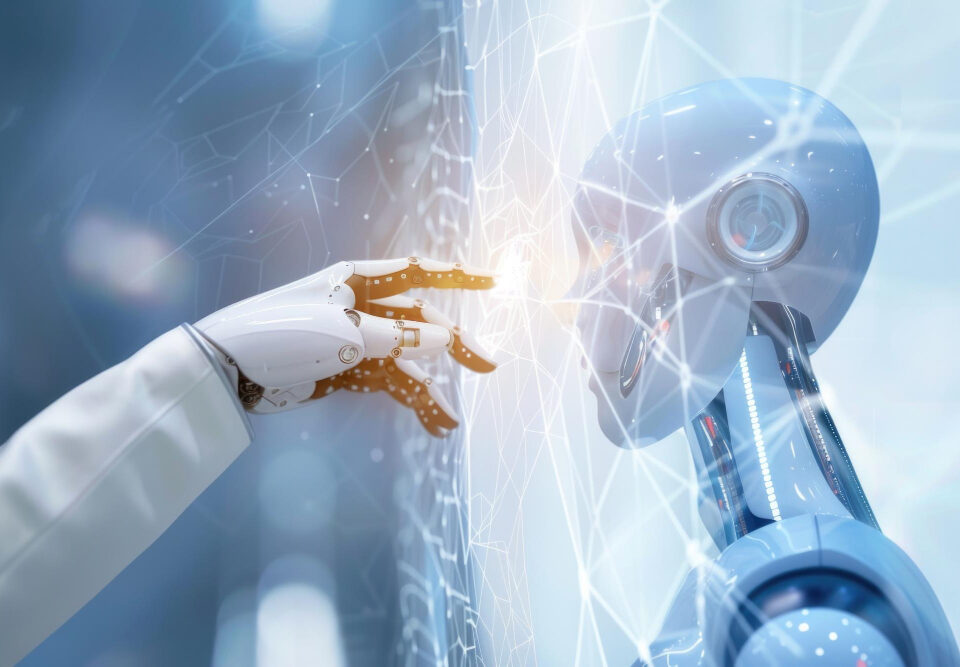- Mail:
- info@digital4pro.com
Il Service Climate: Clima organizzativo

Le sfide organizzative nell’implementazione dell’intelligenza artificiale in azienda
5 Agosto 2025
AI: Il paradosso della produttività
26 Agosto 2025Clima organizzativo e cultura organizzativa
Il clima di servizio è strettamente correlato al costrutto di organizational climate, più di quanto non lo sia, ad esempio, il clima di diversità.
Il costrutto analizzato in questo appuntamento getta le sue origini più profonde nel momento in cui uno dei maggiori ricercatori in materia di organizational climates, Benjamin Schneider, in un suo elaborato[1] anticipò il fatto che limitarestudi ed analisi esclusivamente al costrutto di clima organizzativo costituiva un comportamento “insensato”: secondo l’autore[2] ciò che più rileva ai fini dell’applicazione pratica di tutte le teorie sui climi organizzativi, è il fatto di analizzare l’atmosfera organizzativa in relazione a specifici ambiti applicando determinati criteri d’interesse, piuttosto che utilizzare un gruppo di generiche dimensioni.
Il clima organizzativo e la cultura organizzativa sono due costrutti alternativi per concettualizzare il modo in cui le persone sperimentano e descrivono i loro contesti lavorativi (inclusi non solo le aziende, ma anche le scuole e i governi)[3].
Il clima organizzativo può essere definito come le percezioni condivise e il significato attribuiti alle politiche, alle pratiche e alle procedure che i dipendenti sperimentano e ai comportamenti che osservano essere ricompensati e che sono supportati e attesi (Ostroff et al. 2003, Schneider & Reichers 1983, Schneider et al. 2011).
D’altro canto, la cultura organizzativa può essere definita come le ipotesi di base, i valori e le convinzioni condivise che caratterizzano un ambiente e vengono insegnate ai nuovi arrivati, come il modo corretto di pensare e sentire, comunicate dai miti e dalle storie che le persone raccontano su come l’organizzazione è diventata ciò che è ora, risolvendo i problemi associati all’adattamento esterno e all’integrazione interna (Schein 2010, Trice & Beyer 1993, Zohar & Hofmann 2012).
Fino agli ultimi trent’anni circa, ci sono state differenze significative nei metodi utilizzati per studiare clima e cultura, con il primo caratterizzato da sondaggi sui dipendenti e il secondo da studi di casi qualitativi.
Una revisione storica delle letterature su clima e cultura, tuttavia, rivela che la cultura è stata recentemente studiata molto più spesso utilizzando sondaggi e i problemi affrontati possono sovrapporsi ed essere notevolmente diversi dai problemi affrontati tramite sondaggi sul clima (Schneider et al. 2011, Zohar e Hofmann 2012).
Anche l’interesse relativo della ricerca nei due costrutti è variato nel corso dei decenni. Il tema del clima organizzativo ha dominato le prime ricerche sull’ambiente organizzativo umano negli anni ’60 e ’70, ma è passato in secondo piano quando l’interesse per la cultura organizzativa ha dominato gli anni ’80. Tuttavia, nel corso degli anni Novanta si è verificata un’altra transizione e l’interesse per il clima organizzativo sembra aver eclissato l’attenzione sulla cultura organizzativa negli anni più recenti.
Per illustrare questo cambiamento, esaminiamo articoli in tre delle principali riviste empiriche di psicologia industriale/organizzativa (Journal of Applied Psychology, Academy of Management Journal e Personnel Psychology) dall’inizio del secolo (2000-2012).
In questo appuntamento descriviamo la teoria e la ricerca sul clima e sulla cultura con un focus primario sulla letteratura recente, sebbene inquadrata negli sviluppi storici di entrambi i campi. Inoltre, presentiamo i modi in cui il clima e la cultura organizzativa si completano a vicenda e possono essere reciprocamente utili nella pratica.
Clima organizzativo
Una seria ricerca quantitativa sul clima organizzativo inizia intorno al 1970 (vedere la panoramica storica in Schneider et al. 2011). Le prime ricerche sul clima organizzativo erano caratterizzate da scarso accordo sulla sua definizione, quasi nessun orientamento concettuale alle prime misure progettate per valutarlo e, paradossalmente, un quasi completo ignorare il termine “organizzativo”. Pertanto, le prime ricerche sul clima (diciamo fino ai primi anni ’80) seguivano una metodologia più tradizionale basata sulle differenze individuali che era caratteristica della psicologia industriale dell’epoca. Quando il campo della cultura organizzativa iniziò a esplodere nei primi anni ’80 (dopo l’introduzione di Pettigrew negli studi organizzativi nel 1979), il clima organizzativo svanì sullo sfondo (almeno per un periodo) mentre lottava con la questione dei livelli di analisi. In una certa misura, l’aumento di interesse per la cultura organizzativa negli anni ’80 potrebbe essere attribuito al fatto che sembrava catturare la ricchezza dell’ambiente organizzativo in modi in cui la ricerca sul clima non era riuscita. Come ha osservato Pettigrew (1990, pag. 416), “[C’è] l’impressione che gli studi sul clima siano stati incastrati dall’apparizione nel nido di questo cuculo piuttosto sovralimentato, rumoroso ed enigmatico chiamato cultura organizzativa. Questa pressione da parte di un intruso potrebbe, tuttavia, spingere i ricercatori sul clima a ripensare al ruolo degli studi sul clima”. Pettigrew è stato lungimirante nella sua descrizione della ricerca sul clima, dato che il rinnovato interesse per l’argomento ha prodotto significativi progressi nel pensiero concettuale e nelle metodologie di ricerca (Kuenzi e Schminke 2009).
Il problema dei livelli di analisi
Sebbene i primi scritti organizzativi e gestionali sul clima e sui costrutti simili al clima (ad esempio, Argyris 1957, Lewin et al. 1939) si concentrassero sugli aggregati e non sugli individui, la prima ricerca quantitativa sul clima che proliferò alla fine degli anni ’60 e all’inizio degli anni ’70 fu condotta da psicologi industriali orientati alle differenze individuali (ad esempio, Schneider e Bartlett 1968) e quindi tendeva a concentrarsi sul livello individuale di analisi. Affrontare questo problema fu un obiettivo principale dei ricercatori durante gli anni ’70, con una certa risoluzione emersa negli anni ’80. In breve, il problema era se il clima fosse un costrutto di esperienza individuale e/o un attributo unitario/organizzativo. In altri parole, c’era confusione tra il livello della teoria e il livello dei dati e dell’analisi. Glick (1985) ha sostenuto in modo succinto che a meno che (a) gli elementi dell’indagine sul clima non valutassero il funzionamento organizzativo, (b) i dati non fossero aggregati al livello di analisi organizzativo e (c) la misurazione del clima non fosse focalizzata su importanti risultati organizzativi (ne parleremo più avanti), allora la ricerca sul clima non era diversa da altre ricerche sugli atteggiamenti a livello individuale.
La chiarificazione del clima come attributo del gruppo o dell’organizzazione è stata un passo importante per la ricerca sul clima, sebbene alcuni ricercatori continuino a studiare il clima a livello individuale. Tuttavia, tale ricerca sul clima psicologico (ad esempio, James et al. 2008) non è rilevante per la presente revisione, che riguarda il clima organizzativo. Recenti scritti di Bliese (2000), Chan (1998), Klein & Kozlowski (2000) e LeBreton & Senter (2008) indicano che la ricerca sul clima è meglio caratterizzata come un modello di consenso referent-shift (Chan 1998). Il modello referent-shift utilizza elementi di indagine che fanno riferimento ad attributi dell’unità/organizzazione piuttosto che alle prospettive degli individui. Gli elementi di consenso referent-shift sono concettualmente appropriati perché fanno riferimento al livello a cui le risposte individuali saranno aggregate e tendono a produrre un consenso migliore quando aggregate (LeBreton & Senter 2008). Il consenso implica che le percezioni siano condivise. Le valutazioni della “condivisione” si sono focalizzate sull’accordo tra valutatori e/o sull’affidabilità tra valutatori. L’accordo tra valutatori affronta la misura in cui i valutatori forniscono valutazioni assolute simili del clima in modo che le loro valutazioni siano intercambiabili. La misura più comune di questa forma di accordo nella ricerca sul clima è rWG( J) (James et al. 1984), sebbene siano state proposte altre alternative come l’indice di deviazione media (Burke et al. 1999) e aWG (Brown e Hauenstein 2005). Gli standard comunemente accettati per legittimare l’aggregazione basata sull’accordo sono in genere 0,70 o superiori, sebbene l’utilità di un cutoff ampiamente applicato sia stata recentemente messa in discussione (vedere LeBreton e Senter 2008).
L’affidabilità inter-valutatore affronta la misura in cui l’ordinamento delle valutazioni è coerente tra le persone all’interno delle unità. I ricercatori del clima tipicamente riportano ICC(1), un rapporto tra varianza tra unità e varianza totale (come l’analisi della varianza, o ANOVA; Bliese 2000), e come tale tecnicamente una misura sia dell’affidabilità inter-terrater che dell’accordo inter-terrater (LeBreton & Senter 2008). Sebbene non esistano limiti fermi per ICC(1), James (1982) ha riportato un valore mediano di 0,12 tra gli studi nella sua prima revisione, e LeBreton & Senter (2008) hanno suggerito che valori di 0,01, 0,10 e 0,25 potrebbero essere considerati effetti piccoli, medi e grandi, rispettivamente. È anche comune per i ricercatori riportare ICC(2) [a volte indicato anche come ICC(K); LeBreton & Senter 2008]. ICC(2) è un indice di affidabilità delle medie di gruppo ed è correlato a ICC(1) in funzione della dimensione del gruppo (Bliese 2000), e i valori ICC(2) sono comunemente interpretati in linea con altre misure di affidabilità, con 0,70 o superiore considerati adeguati (Bliese 2000, LeBreton e Senter 2008). Valori così elevati sono ovviamente piuttosto difficili da raggiungere con gruppi di dimensioni più ridotte (ad esempio, 5-6 individui per gruppo). In sintesi, è prassi comune per i ricercatori del clima includere una misura di accordo tra i partecipanti e di affidabilità tra i partecipanti sia all’interno che tra i gruppi per supportare l’aggregazione delle percezioni individuali ai livelli di analisi dell’unità e/o dell’organizzazione. Inoltre, sottolineiamo che una chiave per tale accordo e prova di affidabilità è la formulazione appropriata degli elementi dell’indagine sul clima in modo che rappresentino il livello di analisi a cui verranno aggregati i dati sulla percezione individuale. Un problema di livelli molto recente emerso nella ricerca sul clima riguarda lo studio del clima su più livelli di analisi. Nel corso degli anni, gli studi sul clima “organizzativo” sono stati più frequentemente studi di sottounità organizzative e raramente, se non mai, delle organizzazioni stesse, e ancora meno di più livelli di analisi. Nella loro recente ricerca sul clima di sicurezza, Zohar e Luria (2005) hanno dimostrato un significativo effetto principale sul comportamento di sicurezza sia per le organizzazioni che per le sottounità (gruppi) annidate all’interno delle organizzazioni. Inoltre, hanno dimostrato che il clima di sicurezza delle sottounità mediava gli effetti del clima di sicurezza organizzativo sul comportamento di sicurezza dei dipendenti. Come Zohar e Hofmann (2012) notano, ciò significa che i dipendenti nelle organizzazioni sono in grado di distinguere ciò che accade nelle loro sottounità dal focus organizzativo più ampio sulla sicurezza, ma che le sottounità all’interno di un’azienda hanno più accordo nelle loro percezioni del clima di sicurezza rispetto alle persone nelle sottounità di altre aziende. In breve, i problemi dei livelli sono in qualche modo complessi da concettualizzare perché esistono simultaneamente all’interno e tra le organizzazioni, ma sembra che gli effetti principali a entrambi i livelli abbiano un significato per le persone in esse e per il loro comportamento.
Il focus del clima organizzativo
Un secondo importante risultato della ricerca sul clima organizzativo è lo sviluppo della ricerca sui climi focalizzati. Per focus intendiamo che le prime ricerche sul clima potrebbero essere caratterizzate da scarsa attenzione a qualsiasi cosa oltre a ciò che potrebbe essere definito un clima per il benessere, con una forte attenzione alla leadership e allo stile di supervisione (Schneider et al. 2011). Gli psicologi industriali hanno sviluppato le prime misure del clima che avevano tra 6 e 10 dimensioni, ma le dimensioni scelte per lo studio sembravano coprire una varietà di territori emersi da una varietà di ricercatori. Dato questo approccio concettuale e di misurazione molare al clima, gli studi di validità che utilizzavano tali misure producevano risultati altamente variabili nella migliore delle ipotesi perché la natura generica del clima misurato non era utile per la previsione di risultati specifici. Schneider (1975) riconobbe questo problema e propose che la larghezza di banda e l’attenzione delle misure del clima dovessero corrispondere alla larghezza di banda e all’attenzione del risultato da prevedere. Adottando la tattica di selezione del personale di identificare prima il risultato di interesse, suggerì che le misure del clima seguissero l’esempio. Per chiarire la distinzione tra clima molare e clima focalizzato, ecco cosa potrebbe essere stato un tipico elemento climatico generico seguito dalla versione strategicamente focalizzata dell’elemento: “Il mio supervisore dice una buona parola ogni volta che vede un lavoro ben fatto” contro “Il mio supervisore dice una buona parola ogni volta che vede un lavoro svolto secondo le norme di sicurezza” (Zohar 2000).
I due esempi più diffusi di ricerca sui climi con un focus strategico specifico sono nelle letterature sul clima per il servizio clienti e sul clima per la sicurezza. Uno dei test più efficaci sui risultati del clima di servizio è stato condotto da Schneider et al. (2009), che hanno utilizzato dati longitudinali a livello di analisi dell’organizzazione per dimostrare che le aziende con livelli più elevati di clima di servizio avevano una maggiore soddisfazione del cliente e di conseguenza prestazioni finanziarie superiori.
Quello studio ha replicato molti studi simili sulla relazione tra clima di servizio e soddisfazione del cliente. In effetti, la letteratura sul clima di servizio ora include studi sia sugli antecedenti che sulle conseguenze di esso, nonché studi sui potenziali moderatori. Ad esempio, Schneider et al. (2005) hanno scoperto che il comportamento di cittadinanza orientato al cliente a livello di unità era un mediatore degli effetti del clima di servizio sulla soddisfazione del cliente e sulle vendite a livello di reparto. Quello studio ha anche mostrato che la leadership di servizio era un importante antecedente del clima di servizio. In effetti, la nostra revisione ha mostrato che la leadership è diventata un importante tema antecedente nella letteratura sul clima di servizio. Ad esempio, la ricerca rivela che sia la leadership trasformazionale (Liao e Chuang 2007) che la leadership di servizio (Walumbwa et al. 2010) sono significativi predittori del clima di servizio. Altre ricerche hanno dimostrato che anche le caratteristiche personali del leader sono importanti da considerare, tanto che l’orientamento al servizio di un manager ha dimostrato di mediare completamente la relazione tra le sue autovalutazioni di base e il clima di servizio del suo dipartimento (Salvaggio et al. 2007). Oltre alla leadership, altri antecedenti che hanno dimostrato di prevedere il clima di servizio includono le risorse organizzative e l’impegno a livello di unità (Salanova et al. 2005) nonché le pratiche di lavoro ad alte prestazioni (Chuang e Liao 2010). Infine, in termini di moderatori della relazione clima-risultato, Dietz et al. (2004) hanno dimostrato che il clima di servizio ha avuto effetti più forti quando il contatto con il cliente era più elevato e Mayer et al. (2009a) hanno replicato tale scoperta, dimostrando anche che gli effetti del clima di servizio erano più forti quando il prodotto era più intangibile e quando l’interdipendenza dei dipendenti del servizio era più elevata. La letteratura sul clima di sicurezza ha toccato molti degli stessi temi generali della letteratura sul clima di servizio, inclusa la convalida coerente del costrutto. Pertanto, le prove meta-analitiche supportano la relazione coerente tra clima di sicurezza e incidenti (Christian et al. 2009, Clarke 2006), sebbene Beus et al. (2010b) abbiano suggerito che potrebbero esserci effetti reciproci tra clima di sicurezza e incidenti, tali che livelli aumentati di incidenti influenzano le percezioni condivise del clima (scadente) per la sicurezza dell’unità. Un clima di sicurezza non è solo correlato agli incidenti ma anche alla segnalazione di tali incidenti, tanto che la sottostima è significativamente più alta nelle organizzazioni con cattivi climi di sicurezza (Probst et al. 2008). I antecedenti del clima di sicurezza hanno incluso la leadership trasformazionale generale (Zohar e Tenne-Gazit 2008), la leadership trasformazionale specifica per la sicurezza (Barling et al. 2002), il clima di sicurezza dei livelli organizzativi superiori (Zohar e Luria 2005) e sia le relazioni tra dirigenti e dipendenti che il supporto organizzativo (Wallace et al. 2006). In termini di risultati del clima di sicurezza, una recente ricerca di Neal e Griffin (2006) ha utilizzato dati longitudinali per dimostrare come il clima di sicurezza influenzi la motivazione alla sicurezza a livello individuale e il comportamento di sicurezza, che nel complesso predice i tassi di incidenti nell’unità di lavoro. Infine, ci sono anche prove di moderatori dei risultati del clima di sicurezza. Ad esempio, Hofmann e Mark (2006) hanno dimostrato in un campione di infermieri che il clima di sicurezza ha avuto un’influenza maggiore sulla riduzione di infortuni alla schiena ed errori di medicazione quando la complessità delle condizioni del paziente era elevata.
Oltre a studiare specifici climi mirati per risultati tangibili, gli studiosi hanno studiato i climi per vari processi organizzativi. In questa ricerca, la misurazione del clima mira al processo organizzativo di interesse piuttosto che al risultato strategico di interesse. Alcuni dei primi lavori sui climi di processo si sono concentrati sul clima di giustizia procedurale (ad esempio, Naumann e Bennett 2000). Recenti ricerche in tale ambito hanno dimostrato che il clima di giustizia procedurale potrebbe essere previsto dalle dimensioni del team e dal collettivismo del team (Colquitt et al. 2002), dalla leadership di servizio (Ehrhart 2004, Walumbwa et al. 2010) e dalla personalità del leader (Mayer et al. 2007). Inoltre, il clima di giustizia procedurale è correlato ai risultati a livello di unità come turnover e soddisfazione del cliente (Simons e Roberson 2003), performance del team e assenteismo (Colquitt et al. 2002) e comportamento di cittadinanza a livello di unità (Ehrhart 2004), nonché atteggiamenti a livello individuale e comportamento di cittadinanza (Liao e Rupp 2005, Naumann e Bennett 2000, Walumbwa et al. 2010). Inoltre, gli effetti trasversali del clima di giustizia sono moderati sia dagli attributi individuali (orientamento alla giustizia; Liao e Rupp 2005) che strutturali (distanza dal potere di gruppo; Yang et al. 2007).
Di recente è aumentato l’interesse per un altro clima di processo: il clima di diversità. Sono degni di nota diversi esempi recenti. Ad esempio, McKay et al. (2008) hanno mostrato che i divari nelle prestazioni tra gruppi razziali/etnici erano significativamente più piccoli quando l’organizzazione supportava maggiormente la diversità. Pugh et al. (2008) hanno scoperto che la diversità razziale della forza lavoro era più fortemente correlata al clima di diversità quando la comunità in cui è basata l’unità organizzativa è meno diversificata. McKay et al. (2009) hanno scoperto che i miglioramenti delle vendite unitarie erano più positivi quando sia i manager che i subordinati hanno riferito che la loro organizzazione aveva un clima di diversità di supporto. Infine, Gonzalez e DeNisi (2009) hanno dimostrato che la diversità razziale/etnica era positivamente correlata alle prestazioni organizzative quando il clima di diversità era positivo.
Altri esempi di climi di processo che sono stati al centro della ricerca recente includono il clima etico (Martin e Cullen 2006, Mayer et al. 2009b, Schminke et al. 2005), il clima di empowerment (Chen et al. 2007, Seibert et al. 2004), il clima di voce (Morrison et al. 2011) e il clima per l’iniziativa (Baer e Frese 2003, Michaelis et al. 2010). In effetti, è ragionevole per suggerire che tutti i processi organizzativi potrebbero essere utilmente studiati e compresi attraverso una lente climatica. Ad esempio, si potrebbero concettualizzare in termini climatici processi organizzativi così diversi come il cambiamento organizzativo (Weick & Quinn 1999), la valutazione delle prestazioni (Rynes et al. 2005), la motivazione al lavoro (Latham & Pinder 2005) e la fiducia nelle organizzazioni (Kramer 1999). Lo studio di questi da una prospettiva climatica potrebbe produrre nuove intuizioni sui set di variabili di processo contestuali che sono i loro correlati e forse i loro antecedenti.
In sintesi, il cambiamento verso un risultato strategico e un focus di processo per la ricerca sul clima ha migliorato significativamente non solo la validità della ricerca sul clima, ma anche la comprensione dei contesti che probabilmente producono questi climi focalizzati. In quanto tale, lo sviluppo di questo approccio più mirato ha portato il costrutto del clima a essere più disponibile per i professionisti perché si è letteralmente concentrato su importanti processi e risultati organizzativi e ha indicato pratiche e comportamenti specifici che potrebbero fungere da interventi nelle organizzazioni per migliorare le prestazioni in quelle aree (Burke 2011). Un argomento che deve ancora ricevere molta attenzione dalla ricerca, tuttavia, è la questione del collegamento tra climi di processo e di risultato. Schneider et al. (2011) hanno proposto che i climi di processo potrebbero essere concettualizzati come una base per i climi di risultato. Cioè, quando i lavoratori percepiscono che la loro organizzazione si preoccupa del loro benessere attraverso la sua enfasi su equità, diversità, etica, fiducia e così via, sono più inclini agli sforzi del management di concentrarsi su risultati strategici di valore per l’organizzazione. Schneider et al. (1998) e Wallace et al. (2006) hanno fornito supporto empirico all’idea che i climi focalizzati su risultati specifici richiedono che le fondamenta su cui sono costruiti (climi fondazionali) siano in atto affinché i climi strategici abbiano l’opportunità di emergere. Una recente ricerca di Schulte et al. (2009) supporta questa premessa generale dimostrando che è la configurazione degli elementi di supporto ai dipendenti e degli elementi focalizzati sulla strategia (nel loro caso, l’attenzione al servizio) che conta di più per risultati strategici rilevanti (come performance finanziarie e soddisfazione del cliente). Inoltre, i loro risultati suggeriscono che potrebbe esserci una soglia di clima per il benessere che è necessaria per creare un clima strategico e che un clima moderato per il benessere potrebbe essere sufficiente. Sulla stessa linea, McKay et al. (2011) hanno trovato supporto in un campione di negozi al dettaglio per un’interazione a tre vie tra clima di diversità, clima di servizio e rappresentanza delle minoranze nei negozi per prevedere la soddisfazione del cliente; i grafici di questa interazione indicavano che la soddisfazione del cliente era generalmente più alta quando entrambi i livelli di clima di diversità e clima di servizio erano elevati. Sono necessarie ulteriori ricerche su queste linee che integrino concettualmente climi focalizzati e climi molari e che studino simultaneamente più climi focalizzati.
La forza del clima
In una sezione precedente sui problemi dei livelli abbiamo affrontato la varietà di tecniche impiegate dai ricercatori per difendere l’aggregazione delle percezioni individuali per ottenere un punteggio rappresentativo dell’unità di analisi più ampia di interesse. I ricercatori hanno sollevato più di recente la seguente interessante domanda:
Quali sono le implicazioni dell’osservazione della variabilità nel consenso all’interno delle unità o delle organizzazioni studiate? Questa è una domanda sulla forza relativa del clima tra i contesti e sull’impatto che le differenze nella forza del clima possono avere. L’idea fondamentale alla base della forza del clima non è nuova, essendo correlata al concetto di forza situazionale (Mischel 1976), un costrutto che ha ricevuto un rinnovato interesse negli ultimi anni da Meyer, Dalal e colleghi (Meyer e Dalal 2009; Meyer et al. 2009, 2010). Come ha osservato Zohar (2000; Zohar e Luria 2005), un clima debole può verificarsi quando le politiche e le procedure sono incoerenti e/o quando le pratiche che emergono dalle politiche e dalle procedure rivelano incoerenze. La ricerca sulla forza del clima si è concentrata sul clima molare/generico (ad esempio, González-Romá et al. 2002, Lindell & Brandt 2000) e su una serie di climi mirati, tra cui il clima della giustizia procedurale (ad esempio, Colquitt et al. 2002), il clima del servizio (ad esempio, Schneider et al. 2002) e clima di sicurezza (ad esempio, Zohar e Luria 2004, 2005).
Il modello usuale che guida tale lavoro è che la forza del clima modererà la relazione tra il clima e i risultati di interesse in modo tale che la relazione sarà più forte quando la forza del clima è alta. A livello concettuale, questa interazione è prevista perché più coerenti sono le esperienze dei dipendenti, più è probabile che i dipendenti si comportino in modo coerente come collettivo in modo tale che ci dovrebbero essere più risultati positivi all’estremità positiva e più risultati negativi all’estremità inferiore.
A livello di misurazione, un consenso elevato (bassa variabilità all’interno delle unità) fornisce una media più affidabile e con una media più affidabile ci dovrebbe essere una maggiore validità nella relazione concettualmente rilevante con i risultati. Una ricerca recente ha fornito alcune prove promettenti a sostegno dell’effetto moderatore della forza sulla relazione tra livello climatico e risultati (Colquitt et al. 2002, González-Romá et al. 2002, Schneider et al. 2002). Un interessante risultato corollario dell’articolo di Schneider et al. (2002) è stato che minore era il consenso tra i dipendenti nelle filiali bancarie (più debole era il clima di servizio), maggiore era la varianza nelle percezioni dei clienti delle filiali sulla qualità del servizio ricevuto. Ma non tutti gli studi rivelano un significativo effetto moderatore per la forza del clima nella previsione dei risultati (Dawson et al. 2008, Lindell e Brandt 2000, Rafferty e Jimmieson 2010, Schneider et al. 2002, Sowinski et al. 2008, Zohar e Luria 2004). Dobbiamo essere timidi nel offrire una spiegazione per questa incoerenza nei risultati, ma proponiamo che un probabile problema cruciale presenti un interessante paradosso come segue: i ricercatori del clima hanno trascorso decenni nel tentativo di scrivere elementi per le indagini sul clima in modo che gli indicatori di consenso discussi in precedenza fossero alti, legittimando l’aggregazione. Ma per avere un moderatore deve esserci una significativa variabilità tra le unità nel consenso; se il consenso è uniformemente alto, allora la forza del clima non fungerà da moderatore. In effetti, molti degli studi che non hanno trovato supporto per la forza come moderatore sembrano aver avuto una variabilità piuttosto bassa nel livello di accordo tra le unità (ad esempio, Dawson et al. 2008, Sowinski et al. 2008, Zohar e Luria 2004).
Sono chiaramente necessarie ulteriori ricerche sulle condizioni in cui la forza del clima funzionerà come ipotizzato, ma si stanno iniziando a trovare prove sulle condizioni che hanno maggiori probabilità di provocare climi forti rispetto a quelli deboli. Ad esempio, si è scoperto che i climi sono più forti quando le unità sono più piccole e meno diverse (Colquitt et al. 2002), quando l’interazione sociale all’interno dell’unità è elevata (González-Romá et al. 2002), quando la rete di comunicazione dell’unità è più densa (Zohar & Tenne-Gazit 2008), quando le unità sono più interdipendenti e hanno una maggiore identificazione di gruppo (Roberson 2006), quando le unità sono più coese (Luria 2008) e quando la permanenza media dell’unità è più elevata (Beus et al. 2010a). L’antecedente più comunemente studiato della forza del clima è stata la leadership, con ricerche che mostrano che le unità hanno climi più forti quando i leader sono descritti come coloro che forniscono più informazioni (González-Romá et al. 2002), sono più diretti e hanno modelli di comportamento meno variabili (Zohar e Luria 2004) e sono più trasformativi (Luria 2008, Zohar e Luria 2004, Zohar e Tenne-Gazit 2008). In sintesi, quando le unità di lavoro interagiscono di più, comunicano di più e sono più interdipendenti, e quando i leader comunicano di più e condividono una chiara visione strategica per il lavoro, allora il clima in quelle unità sarà più forte.
Sebbene siano stati fatti progressi nella ricerca sulla forza del clima, ci sono ancora domande a cui è necessario rispondere. Tuttavia, da un punto di vista pratico, ciò che possiamo concludere è che un clima positivo e forte è solitamente superiore a un clima debole e di sicuro è superiore a un clima negativo, quindi le implicazioni per la pratica sono chiare: per massimizzare la probabilità di raggiungere gli obiettivi di performance di processo e risultato dell’organizzazione, è essenziale promuovere in modo coerente e vigoroso un clima focalizzato sul positivo.
Conclusioni
Mezzo secolo di riflessione e ricerca ha prodotto una letteratura significativa sul clima. Forse il risultato principale di questa area di ricerca per la psicologia è stata l’accettazione di un livello di teoria e dati diverso dall’individuo come rilevante e importante nella ricerca e nella pratica psicologica organizzativa. Quindi, la risoluzione del problema del livello di analisi è stata fondamentale per posizionare il clima organizzativo come una forza concettuale integrale e integratrice nel mondo più ampio della psicologia organizzativa e del comportamento organizzativo.
Una testimonianza di questo ruolo ampliato per il costrutto è The Oxford Handbook of Organizational Climate and Culture (Schneider e Barbera 2013), in cui la ricerca e la pratica relative ai principali argomenti della psicologia organizzativa sono affrontate da prospettive climatiche (e culturali). Più specificamente, i capitoli del manuale rivelano modi in cui il clima e la cultura sono entrambi influenzati da e hanno influenza su questioni di psicologia organizzativa più fondamentali, dalla selezione del personale al cambiamento organizzativo. In particolare per il mondo della pratica, l’enfasi sui climi focalizzati (ad esempio, climi per servizio, sicurezza, giustizia, etica) che esiste attualmente ha rivelato intuizioni sui processi organizzativi e sui vari climi che producono per le persone, nonché solide prove della validità delle percezioni del clima per comprendere e prevedere importanti risultati organizzativi specifici come incidenti e soddisfazione del cliente. Sebbene questa attenzione specifica per la ricerca sul clima abbia migliorato la previsione e la comprensione di risultati specifici, i problemi sulla variabilità nella previsione di misure più globali di efficacia organizzativa basate su misure climatiche non hanno ricevuto molta attenzione. In un’eccezione, Kuenzi (2008) ha dimostrato che il clima molare può in effetti essere utile per comprendere le prestazioni globali quando concettualizzato e studiato attraverso il framework dei valori concorrenti (Quinn e Rohrbaugh 1983, Weick e Quinn 1999). Sono necessarie ulteriori ricerche di questo tipo, che utilizzino un quadro e una misura comuni su vari risultati di performance globali.
Sottolineiamo che le organizzazioni non hanno un clima singolare, ma piuttosto molteplici climi simultanei sia di tipo processo che di tipo risultato strategico. Sebbene questo possa essere ovvio, è anche vero che ci sono state pochissime teorie e ricerche sulla questione dei climi multipli (Zohar e Hofmann 2012). La teoria e la ricerca su tali possibili effetti additivi e interattivi di climi multipli sarebbero utili, soprattutto quando tali climi multipli includono sia i focus di processo che di risultato per il clima, nonché i climi molari.
Il clima organizzativo emerge nelle organizzazioni attraverso un processo di informazione sociale che riguarda il significato che i dipendenti attribuiscono alle politiche, alle pratiche e alle procedure che sperimentano e ai comportamenti che osservano essere e alle procedure che sperimentano e ai comportamenti che osservano essere premiati, sostenuti e attesi.
La ricerca sul clima organizzativo si concentra su un risultato strategicamente rilevante (sicurezza, servizio) e/o processo (equità, etica) è superiore nella comprensione di specifici risultati rilevanti rispetto alla ricerca sul clima risultati specifici rispetto alla ricerca sul clima che è generica e non ha un focus specifico.
L’aggregazione delle percezioni individuali del clima in livelli più elevati di analisi è sia attraverso gli item dell’indagine scritti per catturare il clima (essi sono scritti per descrivere il livello al quale i dati saranno aggregati) sia attraverso le procedure statistiche utilizzate per difendere tale aggregazione.
Le ricerche sulla forza del clima (il grado di accordo tra le persone di un’unità nelle loro percezioni) rivelano che la forza spesso modera la relazione tra le medie aggregate del clima e gli esiti del progetto. aggregati di clima e i risultati di interesse.
La cultura organizzativa riguarda i valori impliciti, le credenze e gli assunti che i dipendenti deducono guidare il comportamento, e basano queste inferenze sulle storie, i miti e le esperienze di socializzazione che hanno e sui comportamenti che osservano (specialmente da parte dei leader) che si dimostrano utili e promuovono il successo.
La cultura organizzativa può esistere come un costrutto organizzativo inclusivo per un’intera organizzazione, ma anche contemporaneamente sotto forma di sottoculture (ad esempio, in base al livello nell’organizzazione o alla professione) e anche in modi che suggeriscono una mancanza di integrazione (la cultura organizzativa dell’organizzazione o della professione) e anche in modi che suggeriscono una mancanza di integrazione (la cultura è frammentata).
Le prime ricerche sulla cultura organizzativa si sono svolte prevalentemente con il metodo qualitativo dei casi, ma più di recente le procedure di indagine sono diventate predominanti a causa delle opportunità di comparazione che presentano e per il potenziale che offrono in termini di collegamenti con i risultati della performance organizzativa nei diversi contesti.
L’integrazione della teoria e della ricerca sul clima e sulla cultura ha implicazioni utili per la pratica, soprattutto nei confronti della pratica che produce dati suggestivi di cambiamenti organizzativi che potrebbero produrre miglioramenti nel comportamento e nella performance organizzativa.
Bibliografia
- http://rolandociofi.wordpress.com/2011/06/03/il-clima-organizzativo-di-matteo- ciancaleoni
- https://psyjob.it/clima_organizzativo.htm
- ALDRICH, , & HERKER, D., (1977), Boundary-spanning roles and organization structure. Academy ofManagement Review, 2: 217-230.
- ADKINS A., (1999), Promoting organizational health: The evolving practice of occupational healthpsychology. Professional Psychology: Research and Practice. 30:129–37.
- AZZARITI , BASSINI M., NOVELLO C., (2009), Ma che freddo fa. Appunti, esperienze, evoluzioni intema di meteorologia organizzativa, FrancoAngeli, Milano.
- BASAGLIA S., PAOLINO C. (2015) Clima aziendale. Crescere dando voce alle persone. EGEA, Milano
- BELL, P., (2011), Diversity in Organizations. Florence, KY: Cengage Learning.
- BOLOGNINI (2006), L’analisi del clima organizzativo, Carocci editore, Milano.
- BOWEN E., OSTROFF C., (2001), “Understanding HRM–firm performance linkages: the role of the strengthof the HRM system,” Academy of Management Review, vol. 29, no. 2, pp. 203-221.
- BOWEN, D.E. AND SCHNEIDER, B. (2014), “A service climate synthesis and future research agenda”, Journal ofService Research, 17 No. 1, pp. 5-22.
- BROWN W., SWARTZ T. A., (1989), “A gap analysis of professional service quality,” Journal of Marketing, vol. 53, no. 2, pp. 92-98.
- CAMPBELL J., (1970), Managerial behavior, performance, and effectiveness, McGraw-Hill, New York.
- CARRASCO , MARTÍNEZ-TUR V., PEIRÓ J.M., MOLINER C., (2012), Validación de una Medida de Clima de Servicio en las Organizaciones,Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, 28: 69-80
- CHATMAN A., (2010), Norms in Mixed Sex and Mixed Race Work Groups, Academy of Management Annual
- CHOI Y., DICKSON D., (2010) “A case study into the benefits of management training programs: impacts on hotelemployee turnover and satisfaction level,” Journal of Human Resources in Hospitality & Tourism, 9, pp.103-116.
- COX, , JR. (1993). Cultural diversity in organizations: Theory, research & practice. San Francisco, CA: Berrett-Koehler.
- COX, , JR., & BEALE, R. L. (1997), Developing competency to man- age diversity: Readings, cases &activities. San Francisco, CA: Berrett-Koehler.
- DAVIDSON, C. G. (2003). Does organizational climate add to service quality in hotels? InternationalJournal of Contemporary Hospitality Management, 15(4), 206-213.
- D’AMATO , MAJER V., (2005), Il vantaggio del clima, Raffaello Cortina Editore, Milano.
- DION, K.L., (1989), Ethnicity and perceived discrimination: “A comparative survey of six ethnic groups in Toronto”, Paper presented at the Biennal conference of the Canadian ethnic Studies Association, Calgary, Alta.
- DITOMASO , POST C., PARKS-YANCY R., (2007), Workforce diversity and Inequality: Power, Status, andNumbers, Annual Review of Sociology, 33: 473-501
- DWERTMANN J. G., NISHII L. H., KNIPPENBERG D.V., (2016), Disentangling the Fairness & Discriminationand Synergy Perspectives on Diversity Climate: Moving the Field Forward, Journal of Management, pp. 1–33
- DYER, L. & REEVES, T. (1995) Human resources strategies and firm performance: what do we know and wheredo we need to go? International Journal of Human Resource Management6(3), pp 656-670.
- EISENBERGER , HUNTINGTON R., HUTCHISON R., SOWA D., (1986), Perceived OrganizationalSupport, Journal of Applied Psychology, 71:500-507
- ELY R. J., THOMAS D. A., (2001), Cultural Diversity at Work: The Effects of Diversity Perspectives on Work Group Processes and Outcomes, Administrative Science Quarterly, 46: 229-273
- FOREHAND G. A., GLIMER B.H. (1964) “Enviornmental variation in studies of organizational behavior”,Psicological Bulletin, 62 (6), pp. 205-222.
- FORMISANO , (2009) Analisi del clima organizzativo: il caso di un istituto di credito.
- FURDHAM E GOODSTEIN L.D. (1997), “The Organizational Climate Questionnaire”
- GABRIELLI (2010), People Management. Teorie e pratiche per una gestione sostenibile delle persone, Franco Angeli, Milano
- GABRIELLI , PROFILI S., (2012), Organizzazione e gestione delle risorse umane, Isedi, Torino
- GARDENSWARTZ L.; ROWE A., (1994), Diversity management: Practical application in a health careorganization, Frontiers of Health Services Management, 11: 36-40.
- GELFAND J., EREZ M., AYCAN Z., (2007), Cross-Cultural Organizational Behaviour, Annual Review Psychology, 58:479–514
- GIDDENS, SUTTON (2013), Sociology, Polity
- GLICK H., (1985), Conceptualizing and Measuring Organizational and Psychological Climate: Pitfalls inMultilevel Research, The Academy of Management Review, 10:601-616 GOYAL S., SHRIVASTAVA S., (2013), Organizational Diversity Climate: Review of Models and Measurement, Journal of Business Management &Social Sciences Research, 2:2319-5614.
- HE, , LI, W., AND LAI, K. K. (2011). Service climate, employee commitment and customer satisfaction.International Journal of Contemporary Hospitality Management, 23(5), 592-607. HELLRIEGEL D., SLOCUMJ.W., (1974) “Organizational Climate: Measures, Research and Contingencies”, Academy of ManagementJournal, 17: 255-280.
- HENRY I.G., (2017), “Organizational climate and organizational commitment of deposit money banks in riversstate”, International Journal of Advanced Academic Research, 3: 18-30
- HESKETT, , SASSER W. E. JR., SCHLESINGER L., (1977), The Service Profit Chain: How LeadingCompanies Link Profit and Growth to Loyalty, Satisfaction, and Value. New York: Free Press.
- HICKS-CLARKE, D., AND ILES P., (2000), “Climate for diversity and its effects on career and organisationalattitudes and ” Personnel Review, vol. 29, no. 3, pp. 324 – 345.
- HOFHUIS , VAN DER RIJT P. G. A., VLUG M., (2016), Diversity climate enhances work outcomes throughtrust and openness in workgroup communication, SpringerPlus 2016.
- HOLVINO E., FERDMAN B.M. E MERRILL-SANDS D., (2004) Creating and sustaining diversity and inclusion in organizations: strategies and approaches, in The Psychology and Management of Workplace Diversity, (2004)edited by Stockdale S. e Crosby F.J.
- HONG Y, LIAO H, HU J, JIANG , (2013), Missing link in the service profit chain: a meta- analytic review of theantecedents, consequences, and moderators of service climate, Journal of Applied Psychology, 98:237-67.
- HUBBARD, E., (2012), The Diversity Scorecard: Evaluating the Impact of Diversity on Organizational Performance.New York, NY:
- HUNG, K. (2006). The impact of human resource management practices on service performance of Taiwanese hotel industry – organizational commitment as a mediator. International Journal of the Informationsystems for Logistics and Management, 1(2), 109- 116.
- INNOCENTI L., (2013) Clima organizzativo e gestione delle risorse umane. Unire persone e performance, FrancoAngeli, Milano
- JAMES , JONES A., (1974), “Organizational Climate: A review of Theory a Research”, PsychologicalBulletin, 81: 1096-1112.
- JOHNSON V., (1996), Linking Employee Perceptions Of Service Climate To Customer Satisfaction,Personnel Psychology, 49.
- KOSSEK, E., & ZONIA, S. C. (1993). Assessing diversity climate: A field study of reactions to employer efforts topromote diversity, Journal of Organizational Behavior, 14:61–81
- KOSSEK E., ZONIA S.C., YOUNG W., (1996), The limitations of organizational demography: can diversity climate be enhanced in the absence of teamwork?, in RUDERMAN M.N., HUGHES-JAMES M.W., JACKSON S.E., Selected research on work team diversity, American Psychology association, pp. 121-150
- KRAMER R.M. (1999), Trust and Distrust in Organizations: Emerging Perspectives, Enduring Questions, Annual Review of psychology, 50:569-598
- LEE, W., MITCHELL. T. R., WISE, L. & FIREMAN, S. (1996). An unfolding model of voluntary employeeturnover. Academy of Management Journal, 39, 5- 36.
- LEE, Y-K, NAM, J-H, PARK, D-H., & LEE, A. (2006). What factors influence customer- oriented prosocial behavior of customer-contact employees? Journal of Services Marketing, 20(4), 251-264.
- LEFTON M., ROSENGREN W.R., (1966), Organizations and Clients: Lateral and Longitudinal Dimensions,American Sociological Review, 31: 802-810
- LEWICKI R.J., MCALLISTER D., BIES R. (1998), Trust and Distrust: New Relationships and Realities, Acadedy ofManagement Review, 23: 439-458
- LEWIN , (1939), “Field Theory and Experiment in Social Psychology: Concepts and Methods”, AmericanJournal of Sociology, 44: 868-896.
- LEWIN, K., (1946) Action research and minority problems, in G.W. Lewin (Ed.) Resolving Social Conflicts. NewYork: Harper &Row (1948).
- LITWIN G.H., STRINGER, R.A. (1968), Motivation and Organizational Climate, Harvard University, GraduateSchool of Business Administration,
- LOCKE, A. (1976) The Nature and Causes of Job Satisfaction. In: Dunnette, M.D., Ed., Handbook ofIndustrial and Organizational Psychology, Vol. 1, 1297-1343.
- LYTLE R., HOM P., MOKWA M., (1998). SER∗OR: A managerial measure of organizational service-orientation. Journal of Retailing, 74, 455–489.
- MAJER , D’AMATO A. (2001), “M_DOQ Majer D’Amato Organizational Questionnaire”, Unipress, Padova.
- MANNING, L., DAVIDSON, M., & MANNING, R. L. (2005). Measuring tourism and hospitality employeeworkforce perceptions. Hospitality Management, 24, 75-90.
- MAYER R.C., DAVIS J.H., SCHOORMAN F.D. (1995), An integrative model of organizational trust, Academy of Management Review, 20: 709-734
- MCKAY F., AVERY D. R., MORRIS M. A., (2008), Mean racial-ethnic differences in employee sales performance: the moderating role of diversity climate, Personnel Psychology, 61:349–374
- MCKAY F., AVERY D.R., MORRIS M.A., (2009), A tale of two climates: Diversity Climate from subordinates’ and Managers’ Perspectives and their Role in store unit sales Performance, Personnel Psychology, 62: 767-791
- MINTZBERG H., (1980), Structure in 5’s: A Synthesis of the Research on Organization Design, Management Science, 26: 322-341
- MORAN T., VOLKWEIN, J.F. (1992), “The Cultural Approach to the Formation of Organizational Climate”, Human relations, 45: 19-47.
- MOR BARAK M.E.M., CHERIN D.A., BERKMAN S. (1998), “Organizational and Personal Dimensions in DiversityClimate Ethnic and Gender Differences in Employee Perceptions”, The Journal of Applied BehavioralScience, 34: 82-104.
- MOR-BARAK M.E., CHERIN D.A., (1998), A Tool to Expand Organizational Understanding of Workforce Diversity,Administration in Social Work, 22: 47-64
- MUMBY, D. K. (1988), Communication and paper in organizations: Discourse ideology and nomination in T.Moran, J.F. Volkwein (1992), “The Cultural Approach to the Formation of Organizational Climate”, Humanrelations, 45: 19-47.
- NISHII H., (2013), The Benefits Of Climate For Inclusion For Gender-Diverse Groups, Academy ofManagement Journal, 56: 1754–1774
- OSMAN R., SAHA J., ALAM M.M.D., (2017), The Impact of Service Climate and Job Satisfaction on Service Quality in a Higher Education Platform, International Journal of Learning and Development, 7: 2164-4063
- PARASURAMAN, , ZEITHAML, V.A. AND BERRY, L.L. (1985), “A conceptual model of service quality and itsimplication for future research”, Journal of Marketing, No. 49, April, pp. 41-50.
- PARKINGTON J.J.,SCHNEIDER B.,(1979), Some Correlates of Experienced Job Stress: A Boundary Role Study,Academy of Management Journal, 22:270-281
- PATTERSON M., WEST M.A., SHACKLETON V.J., DAWSON J.F, LAWTHOM R., MAITLIS
- , ROBINSON D.L., WALLACE A.M. (2005), “Validating the organizational climate measure: links tomanagerial practices, productivity and innovation” Journal of Organizational Behavior, 26:379–408
- PRITCHARD D. KARASICK B. W., (1973), The effects of organizational climate on managerial jobperformance and job satisfaction, Organizational Behavior and Human Performance, 9:126-146
- PUGH D., JACK J. D., WILEY W., SCOTT M. B., (2002), “Driving service effectiveness through employee-customer linkages”, Academy of Management Executive, vol. 16, no. 4, pp. 73-84.
- QUAGLINO P., MANDER M., (1987), I climi organizzativi, Il Mulino, Bologna.
- REICHHELD, F., & SASSER, W. E., JR. (1990). Zero defections: Quality comes to services. Harvard BusinessReview, 68:105–111.
- REICHERS, E., & SCHNEIDER, B. (1990). Climate and culture: An evolution of constructs. In B. Schneider (Ed.), Organizational climate and culture (pp. 5–39). San Francisco: Jossey- Bass.
- REYNOSO , MOORES B., (1995) “Towards the measurement of internal service quality”, InternationalJournal of Service Industry Management, Vol. 6 Issue: 3, pp.64-83.
- RHOADES L., EISENBERGER R., (1986), Perceived Organizational Support: a review of the literature, Journal of Applied Psychology, 87: 698-714
- SHANKA T., HOSSAIN M. E., QAUDDUS M. A., (2012), “Perceived quality, satisfaction, and loyalty at the destination level of cox’s bazar, Bangladesh” Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics.
- SHORE M., RANDEL A.E., CHUNG B.G., DEAN M.A., EHRHART K. H., SINGH G., (2011), Inclusion andDiversity in Work Groups: A Review and Model for Future Research, Journal of Management, 37: 1262-1289
- SCHNEIDER , BARTLETT, C.J. (1968), “Individual Differences and Organizational Climate I: The ResearchPlan and Questionnaire Development”, Personnel Psychology, 21: 323-333.
- SCHNEIDER, (1973), “The perception of organizational climate: The customer’s view”, Journal ofApplied Psychology, Vol. 57 No. 3, pp. 248-256.
- SCHNEIDER, (1975). Organizational climates: an essay. Personnel Psychology, 28, 447–479
- SCHNEIDER, , PARKINGTON, J.P. AND BUXTON, V.M. (1980), “Employee and Customer Perceptions ofService in Banks”, Administrative Sciences Quarterly, Vol. 25 No. 2, pp. 252- 257.
- SCHNEIDER, (1980), “The Service Organization: Climate Is Crucial”, Organizational Dynamics, Vol. 9 No. 2, pp. 52-65.
- SCHNEIDER, B., & REICHERS, A.E. (1983). On the etiology of climates. Personnel Psychology, 36, 19-39.
- SCHNEIDER, B. AND BOWEN, D.E. (1985), “Employee and Customer Perceptions of Service in Banks:Replication and Extension”, Journal of Applied Psychology, 70 No. 3, pp. 423-433.
- SCHNEIDER, (1990), The climate for service: An application of the climate construct. In: Schneider, B.(ed.) Organizational climate and culture. Jossey-Bass, pp. 383-412.
- SCHNEIDER, , WHEELER, J.K. AND COX, J.F. (1992), “A passion for service: Using content analysis toexplicate service climate themes”, Journal of Applied Psychology, Vol. 77 No. 5, pp. 705-716.
- SCHNEIDER , BOWEN D. E., (1993) “The service organization: Human resources management is crucial,”Organizational Dynamics, vol. 21, pp. 39-52.
- SCHNEIDER, B., WHITE, S. S., & PAUL, M. C. (1998). Linking service climate and customer perceptions ofservice quality: test of a causal Journal of Applied Psychology, 83(2), 150-163.
- SCHNEIDER, , SALVAGGIO, A.N. AND SUBIRATS, M. (2002), “Climate strength: a new direction for climateresearch”, Journal of Applied Psychology, Vol. 87 No. 2, pp. 220.
- SCHNEIDER, , EHRHART, M.G., MAYER, D.M., SALTZ, J.L. AND NILES-JOLLY, K. (2005), “Understandingorganization-customer links in service settings”, Academy of Management Journal, Vol. 48 No. 6, pp. 1017-1032.
- SCHNEIDER, , MACEY, W.H. AND YOUNG, S.A. (2006), “The climate for service: A review of the constructwith implications for achieving CLV goals”, Journal of Relationship Marketing, Vol. 5 No. 2-3, pp. 111-132.
- SCHNEIDER, B., EHRHART, M.G. AND MACEY, W.H. (2013), “Organizational climate and culture”, Annual reviewof psychology, 64 No., pp. 361-388.
- SCHWARTZ, S.H. (1994), Beyond individualism/collectivism: New cultural dimensions of values. In: KIM, ,TRIANDIS, H.C., KAGITCIBASI, C., CHOI, S. AND YOON, G. (eds.) Individualism and collectivism: Theory,method, and applications. Thousand Oaks, CA: Sage, pp. 85- 119.
- SIMONS T., (2002), Behavioural Integrity: The Perceived Alignments Between Managers’ Words and Deeds as aResearch Focus, Organisation Science, 13: 18-35
- SPALTRO (1977), Lotta contro e lotta per, Celuc Libri, Milano.
- SPALTRO E., DE VITO PISCICELLI P., (2002) Psicologia per le organizzazioni, Carocci, Roma. STORBACKA ,STRANDVIK T., GRÖNROOS C., (1994), Managing Customer Relationships for Profit: The Dynamics ofRelationship Quality, International Journal of Service Industry Management, 5:21-38.
- SUSSKIND M., KACMAR K.M., BORCHGREVINK C.P. (2003) Customer Service Providers’ AttitudesRelating to Customer Service and Customer Satisfaction in the Customer–Server Exchange, Journal of Applied Psychology 88: 179–187
- TAGIURI , PETRULLO L. (Eds.), Person perception and interpersonal behavior, Stanford University Press. (pp. 54-62).
- TETT RP, BURNETT (2003) A personality trait-based interactionist model of job performance,Journal of Applied Psychology, 88:500-17.
- TURNER, C., & TAJFEL, H. (1986). The social identity theory of intergroup behavior. Psychology of intergroup relations, 7-24.
- WIRTZ J., KIMES S., THENG J. H. P., PATTERSON P., (2003), “Revenue management: resolving potential customer conflicts,” Journal of Revenue and Pricing Management, vol. 2, no. 3, pp. 216-226.
- YEO, (2006). “Measuring organizational climate for diversity: a construct validation approach. Dissertation.”Graduate School of The Ohio State University.
- YU C. H., CHANG H. C., HUANG G. L., (2006), “A study of service quality, customer satisfaction and loyalty in Taiwanese leisure industry,” Journal of American Academy of Business, Cambridge, vol. 9 no. 1, pp.126-132.
Note
[1] Schneider, B., & Reichers, A.E. (1983). On the etiology of climates. Personnel Psychology, 36, 19-39.
[2] Schneider, B.
[3] https://www.researchgate.net/publication/230628709_Organizational_Climate_and_Culture