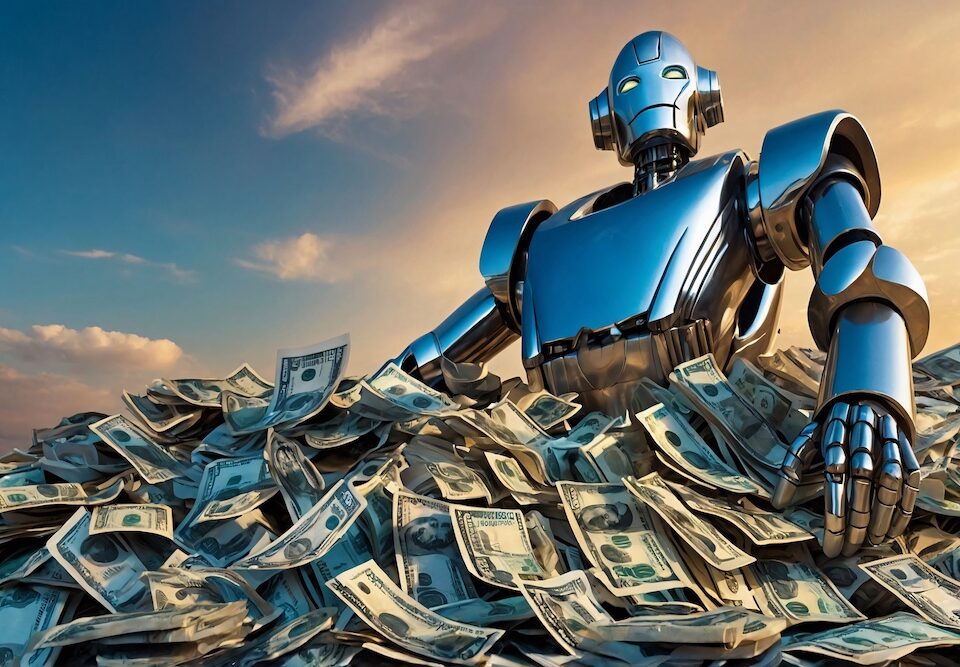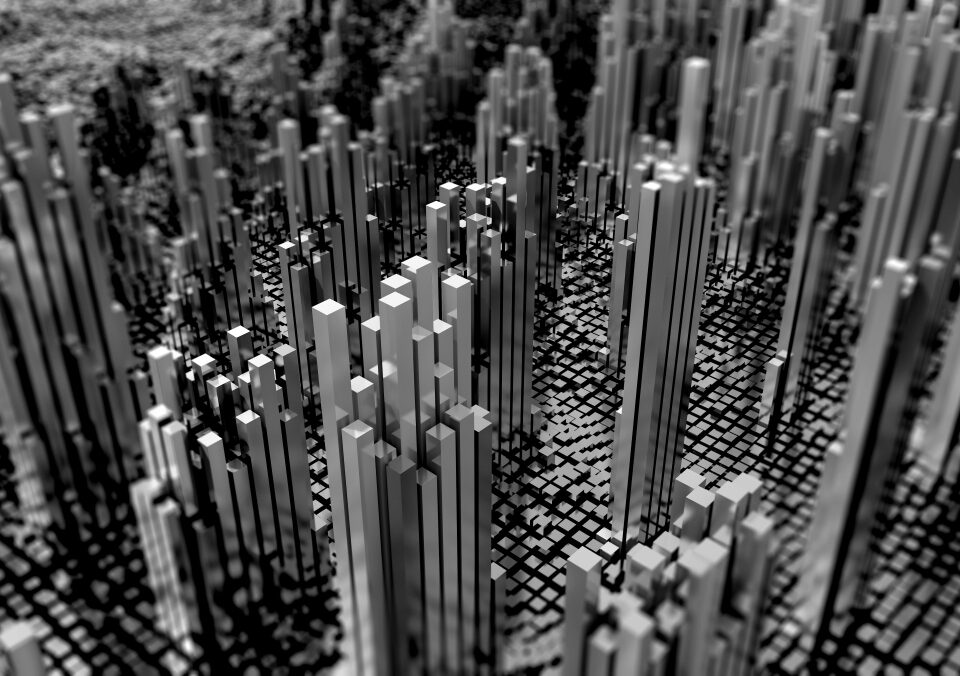- Mail:
- info@digital4pro.com
Smart Roads: Monitoraggio geotecnico e strutturale

Il Diversity Climate: Le origini e le principali teorie di riferimento
22 Aprile 2025
L’impiego dell’AI nella gestione delle risorse umane
29 Aprile 20251. Sistema di Monitoraggio dell’Infrastruttura
Nel corso della vita di un’infrastruttura, è necessario controllare che essa mantenga dei margini di sicurezza rispetto alle prescrizioni minime normative, poiché le azioni di natura antropica e/o ambientale, riducono progressivamente la resistenza delle strutture, come i fenomeni di fatica.
Attraverso un controllo ed un monitoraggio in tempo reale dello stato delle infrastrutture e delle strutture, si potrà ottenere un’ottimizzazione degli interventi di manutenzione preventiva e/o correttiva e – nel contempo – sarà possibile avere un chiaro quadro in caso di calamità, utile per la gestione degli interventi.
I principali sensori IoT, utilizzati nell’ambito del monitoraggio dell’infrastruttura, insieme alle loro funzionalità, sono di seguito elencati.
- Il fessurimetro elettrico è un sensore molto utilizzato per il monitoraggio in continuo di ponti, viadotti, nonché di fratture in ammassi rocciosi. Il dispositivo è costituito da un sensore di spostamento di tipo potenziomentrico in grado di rilevare le variazioni di posizione tra due punti posti a cavallo di una lesione o di un giunto. Il sensore deve essere interfacciabile con qualunque datalogger wireless per il trasferimento dati.
- L’estensimetro è un sensore consente di misurare in continuo le deformazioni e gli spostamenti di infrastrutture viarie come ponti, viadotti e gallerie. Il dispositivo deve essere collegato ad un trasduttore elettrico che trasformi ogni movimento meccanico in una variazione di segnale elettrico con uscita standard 4÷20mA, in tensione o digitale RS485. Il dispositivo deve essere interfacciabile con qualunque datalogger wireless.
- L’accelerometro wireless triassiale ULP (Ultra Low Power) è uno strumento di misura in grado di rilevare e/o misurare l’accelerazione, effettuando il calcolo della forza rilevata rispetto alla massa dell’oggetto (forza per unità di massa). Il sensore è adatto per il monitoraggio in continuo di infrastrutture viarie come ponti, viadotti o anche per il monitoraggio delle barriere stradali. Il dispositivo è dotato di trasmissione radio con antenne omnidirezionali con portata wireless massima di circa 200m.
- L’inclinometro wireless mono, biassiale o triassiale è uno strumento che misura l’angolo che la congiungente osservatore-punto osservato forma con l’orizzontale. È costituito da un ago incernierato che può muoversi su un piano verticale, disponendosi secondo la verticale per effetto della gravità. Il sensore è adatto per il monitoraggio in continuo di infrastrutture viarie come ponti e viadotti. Il dispositivo è dotato di trasmissione radio con antenne omnidirezionali con portata wireless massima di circa 200m.
- L’assestimetro magnetico è uno strumento che misura l’entità dei cedimenti e assestamenti del terreno, più in generale, le variazioni di distanza tra due o più punti lungo un asse verticale comune. Il dispositivo è dotato di una colonna assestimetrica con una serie di punti di misura (anelli magnetici) la cui posizione, rilevata per mezzo di una sonda di lettura, consente di conoscere gli abbassamenti relativi a ciascun tratto compreso tra due anelli e l’abbassamento totale rispetto ad un punto di riferimento. Il dispositivo deve essere collegato ad un trasduttore che fornisca in uscita un segnale elettrico con uscita standard 4÷20mA, in tensione o digitale RS485 e deve essere interfacciabile con un qualunque datalogger wireless.
- Il sensore di temperatura è un sensore che misura della temperatura del manto stradale. Il sensore deve essere in grado di fornire un segnale in uscita 0÷2Vdc, 4÷20mA, o digitale RS485 e deve essere interfacciabile con un qualunque datalogger wireless.
- Il sensore stato asfalto è un sensore che misura le principali caratteristiche fisico-chimiche del manto stradale. Esso permette di conoscere lo stato della strada e quindi avviare azioni di pulizia o di prevenzione contro la formazione di ghiaccio o l’accumulo di neve/grandine. Il trasduttore deve essere in grado di acquisire varie tipologie di informazioni permettendo così di avere oltre la temperatura, anche lo stato del manto stradale distinguendo tra asciutto, umido, bagnato, ghiaccio, neve, sale residuo, consentendo anche una valutazione sull’umidità critica.
- La cella di pressione è un sensore per il rilevamento delle pressioni locali all’interno di una massa di terreno e per il controllo delle pressioni agenti al contatto tra un’opera di sostegno ed un terreno spingente. Il dispositivo deve essere in grado di misurare i sovraccarichi indotti da opere di fondazione e le pressioni al contatto tra opere di sostegno ed il terreno. Il dispositivo deve essere collegato ad un trasduttore elettrico che trasforma ogni variazione di pressione in una variazione di segnale elettrico con uscita standard 4÷20mA, in tensione o digitale RS485. Il dispositivo deve essere interfacciabile con qualunque datalogger wireless.
- La cella di carico a trazione è un sensore per la misura in continuo della tensione delle funi metalliche che costituiscono le reti paramassi. Il dispositivo deve essere collegato ad un trasduttore che fornisca in uscita un segnale elettrico con uscita standard 4÷20mA, in tensione o digitale RS485 e deve essere interfacciabile con qualunque datalogger wireless.
- Il piezometro elettrico dotato di trasduttore di pressione relativo consente di determinare l’altezza piezometrica misurando la pressione idrostatica agente sul sensore immerso e quindi di determinare il livello dell’acqua. Il dispositivo deve essere collegato ad un trasduttore che fornisca in uscita un segnale elettrico con uscita standard 4÷20mA, in tensione o digitale RS485 e deve essere interfacciabile con un qualunque datalogger wireless.
- L’interferometro terrestre è un sensore a tecnologia radar che permette di rilevare da una postazione remota il campo degli spostamenti del terreno attraverso la produzione di immagini georeferenziate e multitemporali, che consentono di seguire in dettaglio l’evoluzione spaziale e temporale del quadro deformativo. Il dispositivo deve essere interfacciabile con un qualunque datalogger wireless.
- Il sensore livello di liquidi è in grado di misurare del livello dei liquidi. Il sensore deve essere costituito da un contenitore e da un galleggiante.
- Il sensore di prossimità ad ultrasuoni, per la segnalazione del superamento della distanza minima di sicurezza dalla barriera stradale.
Per il monitoraggio dell’infrastruttura deve essere previsto uno specifico software che implementa un algoritmo dedicato all’elaborazione dei dati raccolti dai sensori sopra elencati ed all’individuazione automatica delle anomalie della struttura (deformazioni e fessurazioni significative, presenza di danneggiamenti dovuti a degrado dei materiali e/o ad azioni accidentali), sia in termini di localizzazione del danno, che di stima della sua entità.
Le elaborazioni e le analisi delle misure devono essere condotte da tecnici con competenza specifica nel campo della ingegneria delle strutture civili. Un tecnico incaricato del monitoraggio strutturale dovrà emettere un rapporto sullo stato della struttura e sulla eventuale necessità ed urgenza di interventi di riparazione. In ogni caso, il sistema esegue un primo controllo in automatico mediante la definizione di soglie di allarme, le quali devono essere definite dai tecnici che hanno progettato il monitoraggio, in funzione del modello strutturale, del numero di sensori, dalle soglie di sicurezza, ecc.
Il superamento delle soglie di allarme deve essere analizzato da un tecnico che deve emettere un report sulle possibili cause e prevedere in maniera proattiva possibili interventi che possono prevedere:
- Ulteriori indagini sulla struttura;
- Intensificazione della frequenza di monitoraggio;
- Proposte di intervento.
Deve, altresì, essere previsto un sistema di allarme automatico, provvisto delle necessarie ridondanze e sicurezze per ridurre la possibilità di falsi allarmi per avvertire i gestori della infrastruttura e le Autorità Preposte alla Sicurezza nel caso il sistema dovesse rilevare significative anomalie nella sicurezza della struttura monitorata.
Le analisi provenienti dal monitoraggio strutturale consentono al gestore di sviluppare piani di manutenzione associati ai livelli di rischio ed alle esigenze di interventi urgenti, ottimizzando le risorse disponibili per la manutenzione delle strutture.
2. Monitoraggio del piano viabile
Il monitoraggio del piano viabile è finalizzato alla misurazione ed al controllo delle principali caratteristiche fisico-chimiche del manto stradale e permette di conoscere lo stato in tempo reale della pavimentazione, con lo scopo di avviare azioni di manutenzione e di prevenzione, ad esempio contro la formazione di ghiaccio o l’accumulo di neve/grandine.
Lungo l’infrastruttura stradale, verranno installati, in maniera distribuita, i seguenti sensori:
- Sensore di temperatura;
- Sensore dello stato asfalto.
Il primo fornirà informazioni sulla temperatura del manto stradale, al fine di segnalare la possibile formazione di ghiaccio. Lo stato del manto stradale (asciutto/bagnato/innevato/ghiacciato), invece, potrà essere controllato tramite un sensore dello stato asfalto.
3. Monitoraggio delle barriere di sicurezza
Un progetto Smart Road deve prevedere la possibilità di implementare un sistema di sensori posizionati sulle barriere stradali, fisse e mobili, in grado di rilevare la deformazione e la rottura o il danneggiamento della barriera, nonché l’avvicinamento dei veicoli alla barriera stessa. Tali dispositivi devono essere in grado di inviare un segnale di allarme agli operatori ed alla Sala Operativa qualora si verifichi un evento incidentale.
A tale scopo, è stato previsto lo sviluppo delle seguenti funzionalità attive all’interno delle barriere:
- Comunicazione in tempo reale di un eventuale danneggiamento o rottura della barriera stradale a seguito di urto di un mezzo motorizzato, con georeferenziazione dell’evento (carreggiata, direzione e chilometrica);
- Segnalazione di avvicinamento pericoloso di mezzo motorizzato alla barriera stradale attraverso un segnale di allarme comunicato all’utente.
I principali sensori utilizzati per il monitoraggio delle barriere di sicurezza sono i seguenti:
- Accelerometro a shock, per la misura dell’accelerazione e vibrazione derivanti dagli urti alle barriere;
- Sensore di prossimità ad ultrasuoni, per la segnalazione del superamento della distanza minima di sicurezza dalla barriera.
I sensori di accelerazione per la sicurezza del traffico saranno posizionati direttamente sulle piastre di ancoraggio delle barriere. Il sistema di rilevamento degli urti esegue una misura di accelerazione convertendo in digitale le tre uscite in tensione fornite dall’accelerometro triassiale. Il microcontrollore elabora il modulo dell’accelerazione e lo confronta con un valore di soglia, che se superato, attiva lo stato di allerta, deve essere inoltre previsto un sistema di elaborazione dei dati che permetta la localizzazione dell’urto tra due sensori adiacenti.
La distanza tra veicolo e barriera, invece, è ottenuta misurando il tempo necessario affinché l’onda a ultrasuoni si rifletta sul veicolo e ritorni al sensore posto sulla barriera. Se tale distanza è inferiore a un valore di soglia, variabile a seconda della categoria stradale, viene attivato il sistema di allarme e inviata la comunicazione in vivavoce allo mobile device dell’utente stradale. Un’applicazione futura sarà un sistema di comunicazione tra i sensori di avvicinamento e l’autovettura dotata di sistema DSRC, che provocherà un allontanamento automatico del veicolo dalla barriera stradale, evitando così la fuoriuscita dalla carreggiata ed eventuali incidenti.
4. Monitoraggio di ponti e viadotti
Il monitoraggio strutturale svolto nella fase di esercizio è un’attività essenziale per la durabilità e la salvaguardia delle infrastrutture come ponti e viadotti, che devono esercitare la loro funzione per decine di anni.
Nel caso di strutture esistenti, piuttosto datate, il monitoraggio serve a valutare le condizioni strutturali e l’integrità della struttura stessa. Inoltre, consente di mantenere sotto controllo eventuali fenomeni di degrado che si possono sviluppare a seguito di eventi catastrofici o durante la vita della struttura. La loro comprensione e valutazione può costituire un valido aiuto nella corretta definizione degli interventi di manutenzione e ripristino.
Il monitoraggio può coinvolgere gli elementi strutturali che compongono il ponte o il viadotto oppure il sottosuolo interessato dalle fondazioni della struttura. Gli elementi più sottoposti a monitoraggio sono:
- Le travi che compongono l’impalcato del ponte;
- Le pile e le spalle del ponte;
- Le fondazioni.
I sensori IoT utilizzati sono:
- Fessurimetri o Estensimetri, per la misura della deformazioni delle travi degli impalcati e dei pulvini, movimenti dei giunti o fenomeni di fatica della struttura;
- Accelerometri triassiali, per la misura delle vibrazioni della struttura soggetta al traffico veicolare;
- Inclinometri biassiali o triassiali per monitorare inclinazioni e rotazioni delle pile;
- Assestimetri, per il monitoraggio di cedimenti o spostamenti differenziali delle fondazioni;
- Sensori di Temperatura per la misura della temperatura dell’asfalto;
- Celle di pressione, per la misura delle pressioni agenti al contatto tra un’opera di sostegno ed un terreno spingente;
- Inclinometri per il controllo dei movimenti di scivolamento dei terreni;
- Piezometri, per il monitoraggio della falda acquifera.
5. Monitoraggio in galleria
La sicurezza e la gestione delle gallerie esistenti richiedono un monitoraggio continuo soprattutto delle sezioni critiche o di alcune zone già ammalorate, con il fine di conoscere correttamente il comportamento nel tempo di questa particolare struttura.
Gli strumenti diagnostici consentono l’identificazione e la localizzazione di potenziali anomalie, danneggiamenti presenti nella struttura della galleria e sono in grado di generare degli allarmi nel caso di superamento di soglie prefissate.
I sensori che si dovranno utilizzare per il monitoraggio strutturale del rivestimento della galleria sono i seguenti:
- Accelerometri, per la misura di vibrazioni e cedimenti del rivestimento definitivo della galleria;
- Sensore di Temperatura, per monitorare la temperatura del rivestimento della galleria;
- Estensimetri e/o Fessurimetri, per il monitoraggio dei movimenti orizzontali, verticali e convergenze;
- Celle di pressione, per il calcolo delle sollecitazioni e pressioni locali agenti al contatto tra un’opera ed il terreno spingente.
Nelle gallerie di recente realizzazione sono già presenti sensori e impianti tecnologici, come previsto da normativa per la sicurezza in galleria, i quali a loro volta sono connessi a PLC ed al sistema SCADA di galleria. Tale sensoristica misura e monitora lo stato di funzionamento degli impianti presenti, la viabilità e le condizioni di traffico in galleria, la temperatura all’interno della galleria, la velocità dell’aria, nonché le condizioni di visibilità ed inquinamento dell’aria.
6. Monitoraggio dei versanti instabili
Per monitorare correttamente la stabilità di un versante occorre avere quanti più dati possibili per effettuare un’osservazione continua nel tempo del potenziale fenomeno di dissesto.
I principali parametri che dovranno essere sottoposti a monitoraggio sono riportati nel seguente elenco:
- Spostamenti superficiali;
- Stato deformativo del terreno lungo una verticale;
- Profondità e forma della superficie del movimento franoso;
- Collocazione spazio-temporale di eventuali movimenti in atto;
- Aspetti idrogeologici del sito;
- Regime idraulico ed eventuali sue variazioni.
I sensori che più si prestano per il monitoraggio dei parametri sopra elencati sono:
- Interferometro terrestre;
- Inclinometri;
7. Identificazione con TAG RFID
Al fine di facilitare le operazioni di manutenzione ordinaria delle infrastrutture e degli impianti della rete stradale, ciascun apparecchio tecnologico ed infrastruttura stradale lungo la Smart Road deve essere dotato di un TAG RFID.
Il TAG è un elemento “passivo”, in quanto non è in grado di iniziare una comunicazione e sfrutta, per rispondere, l’energia del segnale inviato da un moderno device.
Un TAG contiene almeno un codice identificativo univoco e di sola lettura (UID, o Tid, ovvero l’identificatore di TAG) spesso limitato a pochi caratteri e una memoria aggiuntiva che, in funzione delle scelte, può contenere da poche decine a diverse migliaia di caratteri. La stessa memoria può essere letta e scritta attraverso un protocollo di comunicazione standard (Messaggi NDEF) con cui è possibile salvare dati formattati (quali stringhe di testo, contatti di rubrica, URL web ecc.) e che possono essere interpretati correttamente da ogni reader RFID.
Sfruttando la funzionalità suddetta, tutte le opere infrastrutturali, gli apparecchi elettrici, elettronici ed elettromeccanici, nonché le apparecchiature composite complesse ed i locali tecnici appartenenti alla Smart Road, saranno dotate di TAG passivi accessibili dall’esterno e contenenti gli indirizzi URL web nei quali è archiviata tutta la documentazione (elaborati as-built delle strutture, le schede tecniche dei componenti tecnologici, gli schemi elettrici) e tutte le informazioni necessarie agli operatori.
8. Caratteristiche di sicurezza statica delle strutture
Le modalità di misura e le relative caratteristiche strumentali, da predisporsi a cura del soggetto gestore/concessionario dell’infrastruttura, dovranno consentire di apprezzare in modo chiaro ed inequivocabile lo stato dei componenti critici dell’infrastruttura.
Dovrà inoltre essere progettato il sistema specifico di misura in modo da garantire l’individuazione di stati anomali della struttura (es.: deformazioni e fessurazioni significative, presenza di danneggiamenti dovuti a degrado dei materiali e/o ad azioni accidentali) sia in termini di localizzazione del danno che di stima della sua entità. Tali sistemi di misura potranno anche avvalersi di soluzioni per il monitoraggio satellitare di infrastrutture e territorio.
| TIPOLOGIA STRUTTURA | VARIABILI DA MISURARE |
| Impalcato del Ponte | Per ogni ponte, spostamenti generalizzati e stati deformativi locali |
| Pile e Spalle | Per ogni pila e spalla, spostamenti generalizzati e vibrazioni |
| Gallerie | Per ogni galleria, spostamenti generalizzati e stati deformativi locali |
| Muri di Sostegno | Per ogni muro di sostegno, spostamenti generalizzati |
| Fondazioni in alveo | Per ogni fondazione, scalzamento con misura combinata di stati deformativi locali, spostamenti generalizzati e vibrazioni |
| Paravalanghe | Per ogni paravalanghe, spostamenti generalizzati |
| Frane | Per ogni punto di misura inclinometri fissi a passo 1 m lungo il foro di controllo |
| Barriere in acciaio (tipo guard rail) | Per ogni tratto continuo di barriera, urti |
| Barriere in cemento (tipo New Jersey) | Per ogni modulo, urto e spostamento |
| Barriere stradali mobili | Per ogni modulo, urti |
| Portali segnaletici | Per ogni portale, spostamenti generalizzati e vibrazioni |
Tabella 1 – Caratteristiche di sicurezza statica delle strutture.
Nella tabella che segue sono riportati i risultati attesi della aggregazione delle misure, elaborate ed aggregate in modo tale da consentirne l’utilizzazione diretta per confronto con le previsioni di modelli strutturali descrittivi del comportamento delle opere.
| Misura | Modalità di aggregazione
Modalità di elaborazione ed aggregazione delle misure |
| Impalcato da Ponte
|
Deformata globale e stati tensionali locali
§ Per ogni impalcato § Per l’intera struttura |
| Pile e spalle | Forme modali e relative frequenze
Livelli tensionali locali Deformazione di insieme |
| Gallerie | Deformata del rivestimento e stati tensionali associati |
| Muri di sostegno | Stati deformativi globali |
| Fondazioni in alveo | Variazioni dello stato tensionale nelle pile
Variazioni delle forme modali e relative frequenze Deformazioni di insieme |
| Paravalanghe | Stati deformativi globali e tensionali locali |
| Appoggi e giunti | Movimenti anomali e/o fuori corsa |
| Barriere | Urti |
| Portali segnaletici | Stati deformativi globali ed eventuali variazioni delle forme modali e relative frequenze. |
| Frane | Spostamenti del terreno lungo la profondità e la superficie monitorata |
Tabella 2 – Risultati attesi della aggregazione delle misure.
9. Elaborazione e Aggregazione delle misure
Il trattamento dei dati provenienti dal monitoraggio strutturale (ponti, viadotti, gallerie ecc.) segue un processo analogo a quanto previsto per i dati provenienti dalle infrastrutture viarie. Per tutte le opere, le misure in tempo reale devono essere registrate dal soggetto gestore/concessionario dell’infrastruttura con possibilità di accesso ad un mese di storia nel caso di eventi straordinari (sisma, frana ecc.). I dati disaggregatati riferiti al monitoraggio strutturale devono essere conservati in un repository per un tempo minimo di un mese.
Il primo processo di aggregazione richiede un’analisi via cloud almeno giornaliera, in periodi di presenza e di assenza di traffico.
Le elaborazioni e analisi delle misure devono essere condotte da tecnici con competenza specifica nel campo dell’ingegneria delle strutture civili. Annualmente, o nei casi ove se ne ravvisi la necessità con cadenza superiore, un tecnico incaricato del monitoraggio strutturale dovrà emettere un rapporto sullo stato della struttura e sull’eventuale necessità ed urgenza di interventi di riparazione. In ogni caso, il sistema esegue un primo controllo in automatico mediante la definizione di soglie di allarme. Le soglie di allarme devono essere definite dai tecnici che hanno progettato il monitoraggio e sono stabilite in funzione del modello strutturale, del numero di sensori, dalle soglie di sicurezza ecc.
Il superamento delle soglie di allarme deve essere analizzato da un tecnico che deve emettere un report sulle possibili cause e prevedere in maniera proattiva possibili interventi che possono comprendere:
- Ulteriori indagini sulla struttura;
- Intensificazione della frequenza di monitoraggio;
- Proposte di ri-verifica strutturale;
- Proposte di intervento.
Deve altresì essere previsto un sistema di allarme automatico, provvisto delle necessarie ridondanze e sicurezze per ridurre la possibilità di falsi allarmi, nonché di comunicazione multicanale (SMS, email, ecc) per avvertire i gestori della infrastruttura e le Autorità Preposte alla Sicurezza (VVFF, Protezione Civile ecc.) nel caso il sistema dovesse rilevare significative anomalie nella sicurezza della struttura monitorata. Le analisi provenienti dal monitoraggio strutturale consentono al gestore/concessionario di sviluppare piani di manutenzione associati ai livelli si rischio ed alle esigenze di interventi urgenti. Questo consente di ottimizzare le risorse disponibili per la manutenzione delle strutture.
Bibliografia
- https://www.car-2-car.org/about-c-its
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, DECRETO 28 febbraio 2018 recante “Modalità attuative e strumenti operativi della sperimentazione su strada delle soluzioni di Smart Road e di guida connessa e automatica”.
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MIBILITÀ SOSTENIBILI, MINISTERO DELL’INTERNO, MINISTERO PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE, Decreto recante “Osservatorio tecnico di supporto per le Smart Road e per i veicoli e mezzi innovativi di trasporto su strada a guida connessa e automatica”.
- https://www.fassina.it/news-gli-adas-obbligatori-da-luglio-2024-quali-sono-e-come-funzionano/
- https://www.stradeanas.it/sites/default/files/pdf/Smart_Book.pdf